|
A seguito
della stipulazione dell’accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, il
Governo Libico s’impegnò ad assicurare ai cittadini italiani il visto
di soggiorno in Libia nel rispetto naturalmente delle leggi locali. I
“cari” parenti, ci sconsigliavano di tornare sulla sponda opposta alla
Sicilia, dicendo che la Cirenaica non era più italiana e gli Arabi ci
avrebbero manifestato il loro rancore.
Loro non sanno che i popoli della Libia non
sono abitanti della giungla
 |
|
Cirene. Tempio di Zeus |
Civiltà della Cirenaica
Le popolazioni della Cirenaica
hanno conosciuto la grecità nel VII sec. a.C., l’egizianità nel IV sec.
a.C., la romanità nel 75 a.C., la cristianità nel IV sec. e l’islamismo
nel 624 d.C. Splendono ancor oggi in Libia, a Leptis Magna, a Sabratha,
a Cirene, a Tolemaide, ad Apollonia, i fori, i templi, i teatri, gli
anfiteatri, tipici della civiltà greco-romana-moresca. Il metro
cirenaico della metrica classica è ricordato in Efestione (II sec.
d.C.) ed è usato da Pindaro, Euripide e Aristofane. Illustri personaggi
sono nati in Cirenaica o ne sono stati ospiti: il filosofo Aristippo
(535
a.C.), fondatore della Scuola Cirenaica; il matematico Teodoro
di Cirene (V. sec. a.C.); il poeta Callimaco (310-240 ca a.C.); il
filosofo,
storico,
vescovo di Tolemaide Sinesio di Cirene (370 circa);
Simone il Cireneo, colui che aiutò Gesù a portare la croce; san Marco
evangelista, secondo una tradizione copta, apostolo nell’Egitto,
nella Libia, nella Marmarica e nella Pentapoli; il marabutto Ibn Ghazi
(1450); l’eroe Omar Muktar.
A Bengasi vi erano famiglie di aristocrazia religiosa discendenti di
Maometto, come la Sidi Scerif o la Sidi Sàid (un componente di
quest’ultima, essendo vicerè d’Egitto, diede la concessione per lo
scavo del Canale di Suez, nel 1856, a Ferdinando Lesseps e in sua
memoria fu chiamata Porto Sàid la città sul canale) e famiglie
benestanti, come la Scemsa, che avevano esercitato il traffico
carovaniero prima della guerra italo-turca.
Accoglienza a Bengasi
La mia famiglia decise di partire
per Bengasi nel 1957 da Catania, per mezzo della nave
Ichnusa. I miei genitori erano con la coscienza a posto,
avevano pagato con puntualità e non avevano usato l’imperativo con il
personale, ma il “per favore” e l’indulgenza. Quando sbarcammo, ci
aspettavano al porto di Bengasi, Alì Scemsa, Salah Dneini, Mansur,
Hassen, Mohamed ed altri lavoratori, presso la nostra fabbrica di
bibite analcoliche (gassose, aranciate, sciampagnini, seltz e
sciroppi). La mia felicità, rivedendo queste persone che facevano parte
della mia casa, dopo che fra noi e loro vi erano stati 17 anni di
silenzio e il Canale di Sicilia, con le 36 ore di traversata, fu
indescrivibile. “Come mai siete qui?”. “Siamo qui per voi, abbiamo
saputo della vostra venuta dall’Ufficio Emigrazione. Re Idris vi ha
concesso il passaporto perché vi siete comportati bene con noi, ma non
lo concede a tutti”. Sollevarono mio Padre e lo portarono in trionfo
dalla banchina del porto ad una Ford azzurra. “Privitera! Privitera!”
acclamavano festosamente. Mio Padre, nella sua modestia, non si
aspettava un’accoglienza simile, anche se meritata. “Dov’è Mahmud?”. “È
morto in una lite fra cabile”. Grande dolore. Era quello che mi aveva
regalato il gattino bianco, il cagnolino, il miele, che conduceva la
sua bimba a casa mia, per coltivare l’amicizia, (l’aveva chiamata
Turchia forse a dispetto di chi lo appellava indigeno), che aveva
detto: “Non partire, penserò io per la tua famiglia, vi porterò in un
posto lontano, da dove gli inglesi non passeranno”.
Gli avevo risposto che volevo
studiare, già avevo perduto un anno a causa delle scuole chiuse per i
bombardamenti.
 |
|
I
signori Mahmud, Ramadan ed Alì Scemsa. Mahmud in estate portava un
gelsomino d’Arabia all’orecchio. Il suo
atteggiamento austero era addolcito dal fiore gentile, quasi simbolo
di spensierata goliardia. Il fratello Alì,
figlio di madre diversa, non aveva i suoilineamenti
ed i suoi modi. Accanto una via del quartiere arabo nel 1940.
|
 |
 |
|
La
piccola nave Ichnusa faceva
servizio tra Siracusa e Bengasi.(Ichnusa è l’antico nome della Sardegna
e significa ‘impronta di piede’).
|
Bengasi,1957.
L’Ichnusa si avvia
fuori dal porto con il suo carico di persone e merci, di speranze e
delusioni.
|
Come in sogno, gli incontri
La prima frase che sentii nel
dormiveglia in albergo, fu “Sakr el hosch” (chiudi la porta) che mi
ricordò la voce delle mabruke vicine
di casa di un tempo. Come in sogno ero nella mia terra. L’albergatore
arabo era un tipo di severa moralità. L’indomani, quando andammo per i
quartieri e poi tutti i giorni, dimenticai le assurdità dei “cari”
parenti. Incontrammo arabi che ricordavano a mia Madre la sua umanità.
Chi disse che ogni anno, per il Ramadan, riceveva gratis da parte della
Ditta Zappalà le cassette di gassose, chi rimembrò che quando nacque
sua figlia, gli mandò le aranciate, chi ripescò nel dimenticatoio di
mia Madre, che quando si era trovato in strettezze economiche, aveva
ricevuto da Lei soldi a fondo perduto. Un addetto alle consegne merci
raccontò che quando un cliente italiano, titolare di un bar, lo aveva
maltrattato chiamandolo “Arabo” in senso spregiativo, la Mamma non
aveva esitato a disdire la fornitura e a restituire la cauzione al
cliente italiano (su questo ho un documento). Incontrammo varie volte
un ex cliente ebreo, della via degli Orefici: alto, magro, col
grembiule bianco di sempre, si chiamava Scialoum, era accorato a causa
dei rapporti poco scorrevoli fra Arabi ed Ebrei del mercato vecchio:
non arrivavano mai al peggio, per fortuna! Spesso incontravamo Arabi
che riconoscevano mio Padre e gli tendevano le braccia, con gli occhi
umidi dall’emozione. “Noi Arabi non facciamo entrare uomini in casa. Tu
sei corretto ...” così disse un signore Arabo che ci invitò nella sua
casa e ci mise nella possibilità di cucinare alla siciliana.
 |
|
Bengasi.
Nuovo Teatro Berenice. Sorse sull’area ottenuta spianando una
collinetta già occupata dai ruderi di un vecchio castello turco. Il
comm. H. Nahum della Società teatrale affidò ilprogetto
agli architetti Piacentini e Piccinato di Roma e l’esecuzione dei
lavori all’impresa dell’ing. Andrea Fontana.
|
Nel nuovo
alloggio
Quando ci
riprendemmo dalle fatiche del viaggio e ci orientammo nell’ambiente (la
Tirrenia aveva in dotazione piccole navi che mi facevano soffrire il
mal di mare, dal largo fino all’attracco) gli stessi ex operai, per
metterci più a nostro agio, ci consigliarono di soggiornare in un
appartamentino ammobiliato sito in fondo al viale Regina Elena, oggi
denominato Omar Al-Mukthar. Andavo a comprare il pesce al mercato ben
fornito di freschissimi doni del mare: cernie di scoglio, triglie,
dentici, aragoste, gamberoni, tonni, arselle, bucconi, ricci; un
pescivendolo arabo mi individuava fra i clienti al bancone, si
esprimeva con battute scherzose in siciliano per rendersi simpatico ed
io sentivo la continuità dell’unione fra i popoli, al di sopra della
sporca politica. Un giorno un ragazzino Arabo, di otto-nove anni,
mentre ritornavo dalla pescheria, si offrì di portarmi la spesa e mi
cantò in italiano una canzone di quando ancora lui non era nato. Gli
chiesi: “Qui si parla l’Arabo e l’Inglese, come mai tu mi canti una
canzone dell’epoca dell’Italia? “. “Ho il disco” mi rispose. In un
impeto di commozione gli diedi dei soldi e non gli feci fare lo sciaiel.
Lui mi guardò con aria interrogativa. Certamente quei soldi dati così
avevano leso la sua dignità! Certamente, lui così intelligente avrebbe
gradito imparare l’Italiano conversando strada facendo.
Ricordando
le sere di festa
Purtroppo nei siti
di un tempo non c’erano più i palazzi in stile neo-coloniale delle
Ambasciate, dei Consolati, degli uffici commerciali e legali, non
l’Albergo Ristorante Bar Italia dove diplomati di Conservatorio
eseguivano in orchestra brani di diverso repertorio. Papà, nelle sere
festive d’estate, ci conduceva in questo ritrovo che era di fronte al
giardinetto di piazza del Re; a me che ero all’alba della vita, veniva
il desiderio di far volare le mie dita sulla tastiera del pianoforte,
come quelle del pianista. Lì memorizzavo al primo ascolto tutta la
musica che veniva suonata e che poi ho studiato; seduti al fresco
proveniente dal giardino e dal mare, ci faceva scegliere la
consumazione e sotto il cielo di cobalto e d’argento della Cirenaica,
trascorrevamo ore liete nell’unione familiare. In Italia non ci fu mai
più per me l’atmosfera indimenticabile di quel caffè concerto. Questa
fu la mia adolescenza ricca di armonia.
 |
| Bengasi. Il
Palazzo del Ristorante Albergo Italia e l'edificio della Banca d'Italia |
| Lo Stadio
Municipale |
 |
La
vendetta dei ginn
Tutti gli edifici
che ho nominato erano stati costruiti a Bengasi nella preesistente
grande piazza del Sale, dove sorgeva l’antico castello turco poi
demolito. Da qui, fino al Municipio, si estendeva il cimitero arabo in
stile turco-moresco che fu distrutto con i nuovi piani urbanistici
degli architetti italiani. Il Cimitero arabo era un’oasi di poesia, tra
cactus, tamerici, acacie. In mezzo al verde erano piccole ciotole,
portate dai fedeli per abbeverare gli uccelli. Gli Arabi sentenziarono
che i ginn si sarebbero vendicati. Sembrò che la
sentenza fosse arrivata, con la seconda guerra mondiale, perché
scomparso questo, scomparvero tutti i palazzi che erano stati costruiti
sulla sua area, compreso l’Albergo Italia, bellissimo, con il caffè
concerto, per me favoloso; scomparve un’epoca: 1911-1941. Eliminate le
macerie dei palazzi distrutti dai bombardamenti, ricomparve la piazza
del Sale, arida e scarnificata, cosparsa di pietruzze bianche come ossa
al sole, che facevano ricordare il luogo dell’antico cimitero
profanato.
Ombra di un fiore è
la beltà su cui - bianca farfalla poesia volteggia: eco di tromba che
si perde a valle - è la
potenza.
Il
Castello Turco
Per
il punto strategico sulla costa rocciosa su cui si ergeva, era stato
molto importante, nel corso dei secoli, fino al 1911. Dai suoi
altissimi cammini di ronda si poteva ammirare tutto il panorama di
Bengasi e il mare. Lo sguardo abbracciava il piccolo porto turco, la
lanterna verde, la Giuliana, il ponte, l’idroscalo, il Monumento ai
Caduti, la centrale elettrica, la porta Berka, il luogo dove fu
edificato l’Istituto La Salle, la porta Cammellieri, lo Stadio,
l’Ospedale Coloniale, il palmeto, la
spiaggia di porta Sabry e il faro acquedotto. Il giovedì mattina, il
castello si animava di persone che aspettavano il piroscafo postale
Solunto
o
il
Città di Bastia.
Siccome il fondale del porto era poco profondo, il piroscafo si fermava
un po’ al largo e sbarcava prima i viaggiatori e poi le merci su maone
trainate da un rimorchiatore. Lo sbarco avveniva con delle reti
collegate alle gru. Le reti erano a forma di sacco, con la base
circolare molto solida. I passeggeri, ben stivati, dovevano starvi in
piedi. Ricordo di essermi trovata nel fondo e nella penombra del sacco
quando avevo quattro-cinque anni. Ogni tanto alzavo gli occhi e cercavo
con ansia le facce dei miei genitori, impegnati con i figli più piccoli
di me, non vedevo che pantaloni e gonne e per me era una drammatica
claustrofobia che cessava quando, uscendo dal fondo buio, ricuperavo la
mia famiglia e la luce. Il piroscafo, quando il mare era molto agitato,
specialmente d’inverno, non potendo ormeggiare e non potendo sbarcare
nulla, ritornava a Siracusa. Nel 1960 ho notato che le reti venivano
ancora usate, ma solo per trasbordare cavalli. Il suggestivo Castello
Turco fu distrutto prima che fossero costruiti sul lungomare e attorno
alla piazza del Re gli edifici a cui ho fatto cenno.
Via
Generale Briccola
Da qui, ormai, si
accedeva direttamente alla via Torino ai mercati del pesce, della
frutta e verdura e alla via Generale Briccola, oggi denominata
diversamente. Oh, gli empori dell’anteguerra, pieni di preziosa
mercanzia orientale e occidentale dei commercianti indiani, arabi e
italiani, sotto i portici di questa via! Nelle vetrine mancavano gli
ori, gli argenti sbalzati e bulinati a mano, opere di artigianato
arabo, le collane di perle, i mobili intarsiati con la madreperla, le
pelli di serpente e coccodrillo, le eleganti cinture e borsette dal
vivido colore marocchino. Come un tempo, venivano a trovarmi delle
ragazze italiane, figlie di residenti per lo più temporanei. C’erano
famiglie di siciliani, di greci, versatili e laboriosi, Giudice,
Armenia, Kazourakis, che io ammiravo, i quali pur di lavorare
onestamente si interessavano di tutto, dalle costruzioni edili e
stradali alle industrie navali, al ritiro di botti dalla Sicilia, per
imbottare il vino, perché in quell’autunno si prevedeva una buona
vendemmia.
Bengasi
La storia ci dice
che Bengasi è stata, sin dall’epoca della sua fondazione greca, un
centro di convergenza e smistamento di merci, un terminale di piste
carovaniere e carovane che dal Niger, dal Ciad e dal Sudan, attraverso
il Sahara, trasportavano alla costa prodotti esotici di lusso: zanne di
elefante, ebano, piume di struzzo,
polvere d’oro, pietre preziose, pellami, porpora, schiavi negri,
animali vivi per i giochi del circo, profumi. La Cirenaica produceva il
silfio, un’erba spontanea, ritenuta un portento nella medicina; i
popoli del Medio-Oriente la pagavano a caro prezzo. Il silfio era la
sua maggior fonte di ricchezza. Un grave danno economico portò alla
Cirenaica il decadere
della produzione del silfio, intorno al 75 a.C., dopo che era stata
donata da Tolomeo Apione a Roma. Bengasi fu fondata nel 446 a.C. dai
Greci, col nome Esperide, perché ritenevano che in quei pressi vi
fossero i mitici giardini delle Esperidi. Fu colonia di Cirene e
dominio dei Tolomei d’Egitto. Tolomeo III Evergete la chiamò Berenice
nel 247 a.C. dal nome della propria moglie, figlia di Magas, re di
Cirene. Gli Arabi le commutarono il nome in Marsa Bengasi in onore di
un marabutto ivi stabilitosi nel 1450. (Bengasi
significa figlio del condottiero). Cadde
sotto la dominazione ottomana nel 1578; nel 1911 fu occupata dagli
Italiani. Il suo porto fu ben presto difeso da una diga di 486 metri.
Sopra una striscia di terra emersa, tra due vaste lagune, larga meno di
un chilometro, attorno alla piccola città magrebina, sorse una graziosa
città con palazzi, palazzine e villini, grandi edifici per uffici,
servizi pubblici, un teatro, uno stadio. Nel 1938 contava già 63.681
abitanti. Da Bengasi la ferrovia, dopo aver aggirato la grande sebka di
Ain es Selmani, si inerpica sull’altopiano fino a Barce, mentre la
litoranea si snoda fino a Tocra (la Teucria dei Greci), percorre
l’altopiano del Gebel fino a Derna e ridiscende poi sulla costa presso
il golfo di Bomba.
Il porto di Bengasi, con le difese portuali fu distrutto dagli stukas di Rommel e dai siluri delle sue
navi. Fu ripristinato e riattivato nel corso degli anni, quindi, quando
ritornammo noi, dopo diciassette anni, il porto, l’aeroporto, il soûq e
il fonduk erano in attività come da sempre.
Ricominciare ?
Amia Madre venne
l’idea, vedendo tutte le colline di lana bianca in vendita al fonduk, di comprarne per i materassi,
per il mio matrimonio di là da venire, Madre perfezionista! Qualche
volta andammo a pranzare ai Sahabri,
ove esisteva un ristorante dai tempi di mio Padre. Ne conosceva il
titolare arabo, il quale ci trattava con deferenza e lo ricordo con
stima. L’ambiente era soffuso di penombra, per non far entrare il caldo
esterno. Nelle portate si sentiva il filfil (peperoncino). Il nostro ex
capo personale Ali Scemsa un giorno ci offrì un pranzo di ricetta
grecaal Paradais. Gli Arabi che ci conoscevano esprimevano il desiderio
che noi restassimo a Bengasi e invogliavano i miei genitori a creare
dal nulla qualche industria, come per esempio quella della conserva del
pomodoro.
Ma che cosa dovevano ricominciare quelle anime in pena? Al momento del 10
giugno 1940 erano in buona salute. Mio padre fu richiamato alle armi
all’età di 54 anni, e prestò servizio militare a Bengasi fino alla
caduta del fronte. Con una contraerea risalente alla prima guerra mondiale
doveva rispondere alla pioggia infernale degli aerei in picchiata.
Dopo aver sparato millecento colpi di cannone, quando non ne poté più
e si fermò un attimo, il capitano gli puntò la rivoltella alla tempia.
Nonostante il suo sacrificio e quello dei suoi commilitoni, Bengasi il
6 febbraio 1941 fu invasa dagli Inglesi, dagli Australiani e dai
Legionari d’Algeria che vennero dai Sahabri. Seguì un periodo di tregua e
di assenza di forze dell’ordine.
Un giorno due Australiani ben armati,
(non si saprà mai se entrarono
nella via Sneidel con cattive intenzioni
o per passeggiare) videro mio
Padre dalle sbarre del cancello, perché il portone era crollato, e chiesero di entrare.
Egli era solo, gli operai si erano nascosti nel deserto, la famiglia
era in Italia. Iniziarono a conversare (mio Padre con l’inglese appreso
in gioventù, a Malta); raccontarono di essere venuti dal fronte
egiziano, di essere lontani da casa da tanti mesi, familiarizzarono, si
avvicendarono nella preparazione di diverse portate, pranzarono e i due
soldati libarono alla loro Vittoria gettando i bicchieri a terra, in
segno di festa. Fidando sulla rettitudine di mio Padre e inebriati dal
generoso vino siciliano e dall’atmosfera casalinga, invece di ritirarsi in
caserma chiesero di pernottare a casa nostra. Il mio Papà offrì il
letto grande. Si preoccuparono gentilmente del dove avrebbe dormito
Lui e Lui con noncuranza indicò una sedia.
Raccontò che per precauzione, quando gli
Australiani si addormentarono,
mise il fucile accanto a sé, appoggiato
al muro e finse di dormire. All’indomani
mattina, dopo il caffè delle nostre casse di scorta e dopo la colazione, si
congedarono con sorrisi, strette di mano e tanti good bye, my
friend! Nel periodo di tregua a Bengasi, senza difesa di
polizia, accaddero fatti di sangue fra Arabi, Maltesi e Italiani, per
divergenze ideologiche e per rancori personali. Mio Padre aveva vissuto momenti molto
drammatici e li aveva superati
perché era di una fibra molto forte e di grande forza d’animo,
però tutti
quegli avvenimenti gli avevano lasciato il segno, anche se non si vedeva.
Dov’era la
casa con le terrazze
Fondare l’industria
della conserva in scatola, dopo tutto ciò, non era cosa da nulla.
Quando nel 1911 era giunto a Bengasi mio Padre aveva il capitale, la
giovinezza, la casa, la salute: adesso non c’erano più queste quattro
cose e al posto della casa, delle stanze crollate, c’era un gran
cortile. Vi era ancora lo stesso cancello d’ingresso, il vialetto, ma
senza ombra di aiuole laterali, senza le viti a pergolato, ammirate dai
passanti per i grappoli giganti di uva rosa. Non c’era il giardinetto,
delizia di mio Padre, con fresie, garofani, violacciocche, trombe degli
angeli, ibischi, peperoncini rossi, ranuncoli, gelsomini d’Arabia,
gelsomini di notte, dalie, buganvillee, verbene, agerati, lantane a
seconda delle stagioni. Non c’erano più le terrazze; c’era un mozzicone
di scala (sul quale mi sedetti a piangere e a meditare sulle rovine
della nostra casa e della nostra azienda, come Scipione sulle rovine di
Cartagine), che portava alle terrazze, dove si svolgeva l’epopea degli
aquiloni grandiosi che costruiva mio fratello decenne con i suoi
aiutanti, i fratelli Ernesto e Carmelo Candura. Sulle terrazze veniva
Wanda Busulini. Mi fece conoscere la narrativa: Kipling, London, Delly.
Aveva l’hobby di ritagliare e imbustare le foto delle artiste del
cinema. Il marciapiede vicino a casa era riservato al gioco del carré
sotto lo sguardo di sua madre e di sua zia che ci seguivano dalla
finestra. Le biciclette ci davano la spensieratezza, quando ancora
vivevamo immerse nell’ingenuità ed in famiglie serene. Le terrazze
erano i luoghi delle mie conversazioni con le mabruke (signore) delle
famiglie Raffa e Bahawia: ci vedevamo, io sulle terrazze, loro nei
cortili delle loro case. Mi dicevano: “Vieni!”. “Perché non vieni tu?
Io sono venuta da te!”. “Rascel (marito) non permette”. A quel tempo le
spose e le ragazze arabe giovani avevano l’obbligo di stare a casa.
Volevo bene alle mie vicine. Non conoscevamo bene le rispettive lingue,
la conversazione finiva presto, tra brevi domande e amichevoli sorrisi.
Erano e sono pronte al dolce sorriso, le donne della mia Bengasi. Forse
ciò è dovuto a uno stile, forse alla solarità del luogo, forse al
sentirsi amate. La donna nel mondo arabo, sia giovane che anziana,
anche se alcune leggi e tradizioni fanno pensare il contrario, è tenuta
in grande considerazione.
La
fabbrica di bibite
Della fabbrica di
bibite analcoliche (gassose, sciampagnini, aranciate, seltz, sciroppi)
i cui macchinari erano stati rinnovati da mia Madre poco tempo prima
dello scoppio della guerra, ora non esisteva più nulla. Ci fu detto che
gente venuta dall’Egitto li aveva portati via. (Ma andrebbe bene un
commento del Manzoni). Mia Madre diceva: “Bisogna fare buon viso a
cattivo gioco” e piangeva vedendo in fumo il lavoro di tanti anni.
Alì la consolava:
“Sagnura, perché piangi? Ormai ...!”. Mio Padre diceva nella sua lingua
madre: “Pacienza!”. I locali della fabbrica erano abitati da
un uomo di colore il quale non ci aprì la porta e mandò a dire per
mezzo del nostro accompagnatore che doveva dormire, avendo lavorato nel
turno di notte. Invitati con la socievolezza di un tempo, ci recammo in
auto o in carrozza al bosco del Fojat, alla Giuliana, con Arabi
metropolitani. Pranzammo e pernottammo a Barce presso la famiglia
Giudice, di
Gela. Per la prima volta ammirai dal Gebel il panorama della vasta pianura di Barce, con
le case coloniche abbandonate da una parte dei Ventimila; nel bosco
del Gebel raccogliemmo fiori simili a mughetti e fragole selvatiche,
notammo delle nidiate di tortorelle le quali non temevano gli umani e
non si nascondevano fra i cespugli.
Gli Arabi cirenaici non vanno a caccia
di uccelli, li considerano creature
di Dio: può darsi che i sentimenti di S. Francesco siano arrivati fin qui nel 1274 con il
primo missionario francescano, il Beato
Corrado Miliani da Ascoli, quando
approdò in Libia, oppure, viceversa,
San Francesco li aveva appresi da loro. Gli Italiani vanno a
caccia di gazzelle nel Sud di Bengasi. Il bosco era costituito da fitta
macchia mediterranea; vi notammo ragnatele
argentee estese fra i rami. I miei
genitori non prediligevano le gite a
lungo raggio. La Mamma, titolare
della fabbrica, era scrupolosa per la qualità e l’igiene della sua
merce, sorvegliava personalmente il lavoro dei suoi dipendenti, lavorava
accanto a loro per dare il buon esempio. Stava in guardia dalla
concorrenza sleale. Una volta fu denunciata di usare la saccarina invece
dello zucchero ma tutto fu smentito dalle analisi dell’Ufficio
competente. Si seppero le generalità di colei che aveva fatto questa cattiva
azione alla ditta Zappalà: era una, venuta in visita come dirimpettaia, alla quale mia
Madre aveva offerto l’aranciata! I miei genitori non partecipavano a
vita di società, di sera. Da sposini avevano presenziato a spettacoli
di operetta. Quando io e mio fratellino siamo cresciuti, la nostra
famiglia cominciò a frequentare il cinema Berenice, prediligendo films
di commedie musicali, con Fred Astaire, Beniamino Gigli, ... La Mamma
oltre che della fabbrica, si occupava della cucina, della casa, dei
figli. Quando avevo tre anni e mezzo, eravamo quattro figli, Francesca,
Cosimo, Silvia e Lidia. Venivano mabruke per lavorare. “Sagnura
lavorare sabun (sapone)?”. I ragazzi più svelti della fabbrica lavavano
la fabbrica, i pavimenti della casa e il cortile tutti i pomeriggi,
prima di ‘staccare’.
RICORDI
Ricordo qualche gita sociale di
prammatica; lunghe tavolate sotto gli eucalipti del Fojat; il ragionier
Ravaioli che declamava poesie, forse era il lunedì di Pasqua o il Primo
Maggio; ricordo altre tavolate alla Casina del Lete.
Mariuccia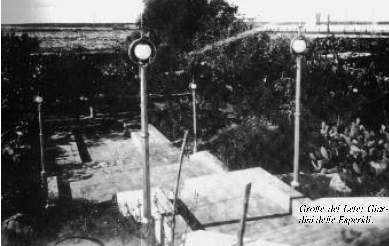 |
|
Grotte
del Lete: Giardini delle Esperidi.
|
Ricordo una festa di matrimonio
nella famiglia Bahawia. Fui invitata ad assistere alle danze del ventre
molto semplificate, accompagnate dal ritmo della darbuka (tamburello)
e ai loro riti, come per esempio quello di una mabruka anziana che
diffuse sulla porta d’ingresso della stanza degli sposi un rosso d’uovo
augurale e propiziatorio. Ricordo una passeggiata di sera con mio padre
il quale mi condusse a vedere una fitta schiera di navi e barche in
gran pavese sul lungomare. Queste brillavano per tutte le luci accese
multicolori e i lampioncini cinesi in onore della visita del re
Vittorio Emanuele III. Ricordo
l’inaugurazione di una villa alla Giuliana. I miei genitori erano al
lavoro e vi andai con mio fratello. I pavimenti delle sale erano
in marmo istoriato a
mosaico; in una di queste campeggiavano un pianoforte e un grande
dipinto a olio, raffigurante una notissima personalità politica a
cavallo. Passando per via Torino avevo visto mentre il pittore lo
dipingeva. Nella maestosa figura del padrone di casa,
proveniente dalla provincia di Siracusa, vedevo un biondo ammiraglio
vichingo o un dio greco. Dopo 17 anni era a Bengasi per le nozze della
figlia Maria e per lavoro. Egli era una mente poliedrica, diede ai miei
genitori preziosi consigli, si chiamava Concetto Giardina. Si occupava
di industrie navali e negli ultimi tempi anche di industrie agricole.
Ricordo un’allegrissima gita scolastica in treno, quando mi sentii
tanto felice, perché improvvisandomi una Mariele Ventre, insegnai una
canzone di mia Madre alle compagne del mio scompartimento che cantarono
tutte in coro:
Compagne salutiamo
la pianta piccolina e il giorno ricordiamo in cui piantata fu ...
Forse era la festa
degli alberi.
Ai tempi di nonna Isabella
Quando me ne parlava
mia Madre, da bambina, con la mia preparazione elementare, vedevo i
fatti storici di mia nonna come molto lontani nei secoli: invece, dalla
legge del 1887 al 1943, quando rientrammo a causa della guerra del
1940, ad Acireale, città di origine, erano trascorsi soltanto 56 anni.
Nel 1650 fu rinvenuta una sorgente, in mezzo alla durissima lava, da un
certo Andrea Cantarella, dopo un terremoto, nel territorio del Comune
di Aci S. Antonio e S. Filippo, che proprio nel 1640 si era separato
dal Comune di Acireale. I lavori di scavo durarono dal 1660 al 1667 e
nel 1852 venne calcolata una portata di 50 l/s.
 |
 |
|
Acireale.
Chiesa di S. Maria del Suffragio.Affresco di P. Paolo Vasta: L’Angelo
indica ad Agar la fonte per dissetare Ismaele.
|
Acireale.
Chiesa di S. Maria del Suffragio. Affresco
di P. Paolo Vasta: Giobbe visitato e consolato dagli amici
|
 |
|
Santa Venera.
Cittadina Patrona della città di Acireale. Le gemme, i monili, gli ex
voti che adornano il simulacro della Santa sono doni offerti alla
Patrona da Vescovi, operai, mamme, fanciulli, professionisti,
industriali ... e sono la testimonianza di grazie ricevute. Quattro
bacheche custodiscono le medaglie dei combattenti che dicono la
devozione degli Acesi nei momenti di pericolo e la protezione della
Santa Patrona contro la peste bubbonica del 1573, contro la
pignorazione feudale del 1518, contro la vendita del comune di Aci del
1656(da
parte della Corte di Spagna), contro varie eruzioni, vari terremoti,
contro l’assedio dei Francesi e Spagnoli che non
osarono sterminare la città (1676-1678), contro il bombardamento
del
4 novembre 1941.
|
Il principe Stefano Riggio di
Campofranco e Campoflorido nel 1672 comprò il dominio del Comune di Aci
S. Antonio e S. Filippo; nel 1685 vinse la disputa per la ricca
sorgente col Comune di Acireale, il quale rivendicava parte dell’acqua.
Il Principe, dopo aver vinto, incanalò l’acqua attraverso una ‘saja’
che sfociava al mare, lungo la quale furono costruiti dei mulini di
proprietà sua, per un presunto numero di sette. La ‘saja’ presenta una
larghezza e una profondità di circa 50 centimetri. Questo percorso di
acqua diede vita ad una serie di attività agricole e industriali dal
1685 in poi. L’acqua della ‘saja’ al secondo mulino faceva un salto di
circa sette metri; al terzo mulino si ammirava una cascata di 3,5
metri. Il secondo mulino rimase in attività fino agli anni trenta. Il
terzo mulino rimase in attività fino agli anni quaranta. Il quarto
mulino è ormai avvolto dall’edera e si perdono le tracce sia della
‘saja’ che dei rimanenti mulini. A Capo Mulini prosperavano le
concerie, a Reitana e Baracche prosperavano le coltivazioni di luppolo,
di barbabietole da zucchero, le risaie, con produzione
di pelli, lupini, zucchero e riso.
Queste attività sono tutte estinte, tranne quella dei lupini che si
vendono ancora nei mercati e sulle spiagge. Una conceria sopravvisse
fino a 50 anni fa, quando l’ultimo rappresentante, compagno di scuola
di mio fratello Cosimo, emigrò nella Repubblica Sud-Africana; si chiama
Salvatore Musumeci. Partì col cuore pieno di amarezza, ho una lettera
del 25-1-1957, scritta a mio fratello, ove se la prende con questo e
con quello, perché non è consapevole che l’industria di Acireale è
entrata storicamente in un vicolo cieco. Suo padre, dopo la sua
partenza morì di dolore come mio nonno Agostino Zappalà, marito di mia
nonna Isabella Toscano, di cui dirò fra poco. Le persone di oggi si
limitano a brevi commenti su questi fatti e la conversazione cade,
dicono che i proprietari d’industrie fallirono a causa delle tasse e
della mancanza di richiesta di merce sul mercato; non si rendono conto
che fu la legge del 1887 a scatenare i fallimenti. Mio nonno, notando
che il commercio della seta era fermo, cre dette di alzare l’ingegno
impiantando un pastificio: mal gliene incolse, non comprese (nel
Meridione d’Italia non vi erano molti mezzi d’informazione, come nel
Nord ad opera degli Asburgo) che il vento della politica aveva cambiato
direzione alle industrie del Sud. Era in atto la sostituzione dei ceti,
come si legge anche nel Gattopardo; i nuovi ricchi
volevano braccianti per coltivare i loro immensi feudi e agli ex
proprietari di industrie che facevano la fila per lavorare a giornata i
soprastanti dicevano: “A te niente perché hai le scarpe”,
con arroganza. Mio nonno quando si accorse che non gli davano nemmeno
il lavoro declassato e che la fila delle anticamere si allungava,
smontò i macchinari del pastificio, smise di arrampicarsi sugli specchi
e morì di crepacuore. Dopo di ciò, mia nonna fu consigliata dal suocero
e dai suoi fratelli che erano emigrati, uno a Bronte, uno a Marsiglia e
uno a Parma, a gestire un negozietto di pasta, pane, farine e generi
alimentari. Crebbe i suoi figli religiosamente. Spesso si sentiva
oppressa dalle circostanze e piangeva. Quando si asciugava le lacrime,
trovava consolazione nella sua cultura e i versi della Divina Commedia
erano la sua riserva: “Nessun maggior dolore - che ricordarsi
del tempo felice - nella miseria”. Un giorno mi fece vedere
dei vestiti eleganti nell’armadio: “Nonna, questi vestiti così tarlati
di chi sono?” le chiesi. Lei mi rispose: “Sono miei, li indossai fin
quando visse il nonno, poi dopo il suo lutto, altri lutti, fui in nero
per sempre”. Chissà da quanti anni non apriva quelle ante per non
‘renovare dolorem’. Tra quegli abiti me ne rimase impresso uno bordeau.
Lei disse ancora: “Ero bianca, rosea, bionda, questo colore mi donava
molto”. Ne accarezzò la taffetà di seta frusciante, apparteneva a
momenti indimenticabili, quando incedendo con il marito e i bimbi,
riceveva con gli ossequi i complimenti: matrona romana; bella come
Santa Venera (patrona di Acireale). Passò ai posteri come persona
generosa. Un compagno di ginnasio, il cui padre poco pensava a lui, si
ricordava: “Tua nonna mi regalava i panuzzi quando ero bambino”. Per
evitare alle sue tre bambine le sorprese di un ipotetico cattivo
patrigno rimase, per sua scelta, nello stato di vedovanza, consigliata
anche dal Parroco. Le sue bambine frequentarono sin dall’asilo la
scuola delle Suore di Maria Ausiliatrice e rimasero affezionate al
collegio fino a grandi. La nonna abitò fino alla sua morte in un
appartamentino con un balconcino che dà sulla piazza Commestibili,
ubicato in una breve strada accessibile sia dalla piazza della basilica
di S. Sebastiano che dalla piazza Commestibili. Da quel balconcino non
poteva più ascoltare le liriche di suo padre al pianoforte, perché si
eseguivano ben altre musiche in piazza. Nonna Isabella, aveva un cugino
capitano di lungo corso. Durante una tempesta la sua nave era affondata
al largo di Siracusa e lui fu dichiarato disperso. Da allora non volle
mai muoversi dalla Sicilia per paura della traversata, né venire a
Bengasi, né andare in America, invitata da cognate, parenti e
conoscenti che si erano rimessi bene in sesto, senza rimpianti, dopo la
disfatta economico-sociale, causata dalla legge del 1887. Morì
all’improvviso prima dei 60 anni. Pur avendo cresciuto quattro figli,
di cui una mancò da ragazzina a causa della ‘spagnola’, quando successe
la disgrazia era sola. Due figlie erano in Cirenaica, il maschio in
Francia. L’ultima volta, quando eravamo venuti in Sicilia, forse
presagendo la sua prossima fine, aveva pregato la Mamma di portare con
sé a Bengasi, l’antico oro dei tempi dei fasti della seta. La Mamma
aveva risposto: “Ancora sei giovane, non sarebbe gentile da parte mia
accettare, perché mi sembrerebbe di spogliarti da viva”. L’oro perciò
rimase nella casa della nonna; il figlio arrivò per primo dalla
Francia, non trovò l’oro, né i soldi che servivano alla nonna, per fare
le levate della merce: i cassetti erano letteralmente svuotati.
Mariuccia
L’ultimo ricordo di
mia nonna, Isabella Toscano, è questo: ero ospite di lei, in Sicilia,
stavamo usufruendo della licenza di mio Padre, avrò avuto sette-otto
anni, era il mese della Commemorazione dei Defunti, che per i bambini
fuori dalla Sicilia corrisponde alla festa della Befana; ero uscita con
la Mamma; le strade adiacenti alla piazza del mercato, erano affollate
di persone e bancarelle, sulle quali erano in evidenza dolci e
giocattoli. Passando e guardando, mi innamorai di una bambola, si
chiamava Mariuccia; era alta, snella ed
elegantissima, aveva i boccoli biondi, il vestito e la mantellina di
seta rosa, come il cappellino a falde larghe. La gonna era lunga e nel
fondo vi era inserita la crinolina; l’orlo del vestito, della
mantellina e delle falde del cappellino erano bordati da un boa di
cigno tinta su tinta; aveva il punto vita sottolineato da una cintura
di raso. Il suo bel viso era adornato da orecchini e buccola in
similoro. Volevo Mariuccia, ma mia Madre non ne
volle sapere. La nonna Isabella mi vide da lontano piangente, me ne
chiese il motivo e prendendo la borsa alla svelta: “Andiamo, dimmi
dov’è che te la compro io” mi disse risoluta.
Così ritornai con la
bambola desiderata, che era più alta di me. Mariuccia
rimase a Bengasi, insieme alle altre mie bambole più piccole, tutte
nello stesso scatolone di Mariuccia, ben ordinate e
nuove, perché a differenza della maggioranza delle bambine, mi beavo a
guardarle e custodirle, e a sapere che erano mie; non le sciupavo
lavandole, spettinandole, vestendole e martirizzandole, in ultimo
facendole finire chissà dove.
Dolori e lutti familiari
Noi oggi risiediamo
in Italia a causa della catastrofe di guerra, abbiamo nostalgia della
nostra terra e casa lontana, come se esistesse tal quale l’abbiamo
lasciata ma, a volerci pensare, laggiù la vita non fu tutta rose e
fiori. Le spose
che si sistemavano in Africa
settentrionale, restavano quasi
sempre staccate dalle loro madri, che tanto aiutano quando
ci sono neonati.C’era mortalità infantile a causa del clima e non tutti
gli organismi si adattavano al ghibli.
Lidia a pochi mesi fu vittima
dell’enterocolite. Silvia
perse la vita travolta da
un camionista, nel giorno di Santo
Stefano, aveva quattro anni e
mezzo. I gemelli Agostino e Giovanni,
di sette mesi, morirono per aborto a causa del ‘colpo’
che venne alla Mamma,
per un telegramma scritto senza
precauzioni, annunciante la morte
improvvisa della nonna.
 |
 |
|
Bengasi. Il Cimitero Cristiano |
Bengasi. Lungomare. Veduta della Dogana e del tribunale |
Lezioni materne
Ritornando alla
fabbrica, la Mamma mi diceva che tra i suoi concorrenti vi erano quelli
che si mettevano avanti in mezzo ai debiti; alle prime difficoltà e
alle prime mancanze di guadagno, si trovavano perseguitati dai
creditori, abbassavano la qualità del prodotto, questo non veniva
richiesto e fallivano. Lei, anche se d’inverno lavorava poco, pagava lo
stesso gli operai. Non aveva l’assillo del padrone di casa, dell’orzo
per i cavalli, dei sacchi dello zucchero da pagare. Lo zucchero
arrivava dalla Eridania Sampierdarena, la polpa d’arancia e l’acido
citrico, dal dott. De Franco, Via Sant’Orsola, Catania; le essenze
degli sciroppi, le bottiglie da Napoli, le bombole e altro ancora da
Bengasi. Tutto era pagato subito e in contanti. Lei non abbassava la
qualità del prodotto e andava avanti. Questa è un’autentica lezione di
Economia e Commercio che Lei mi spiegava quando si parlava del più e
del meno. Questa tesi, l’ho sentita discutere agli esami di laurea in
Economia e Commercio, all’Università di Catania da un giovane,
cinquantadue anni dopo che me ne aveva parlato Lei. Aveva portato in
dote £. 6.000 (seimila) con la quale aveva comprato in contanti il
locale della fabbrica, il deposito delle bottiglie, i macchinari, la
scuderia, i cavalli, i carri. Essendo rimasta orfana a quattordici
anni, aveva l’assillo di crescere bene i suoi figli e di bene dotarli.
Non sempre nel 1941, arrivavano i soldi che mandava mio Padre dal
fronte, questi dovevano bastare per il sostentamento e la scuola di noi
figli in Italia, con la speranza del ritorno a casa. Sebbene non ci
fossero più le entrate della fabbrica, la Mamma saltuariamente aiutò la
famiglia di mia zia Venera, profuga da Bengasi come noi, il cui marito,
senza lavoro, morì qualche anno dopo il rientro in Italia. Diverse mie
compagne che erano nell’età dello sviluppo, finirono chi al sanatorio,
chi al cimitero, per la mancanza del proprio clima, sostentamento,
casa, lavoro. La Mamma, che era andata a Roma nel tentativo di trovar
casa, incontrò in questa città la mamma di una mia compagna a cui
raccontò, piangendo, la storia della professoressa di Scienze che mi
aveva fatto perdere un anno di scuola, impedendo il ricongiungimento
della famiglia dalla Sicilia a Roma. “”Lei piange per sua figlia che ha
perso un anno di scuola ma sua figlia è viva. Cosa dovrei fare io che a
causa della fame e del freddo ho perso mia figlia per sempre?”.
Piansero insieme. Le compagne di scuola, chi le vide più? Tutte
rientrarono al proprio paese di origine, molte si stabilirono a Roma;
non avemmo il conforto di consolarci a vicenda.
 |
| Venera Zappalà,
sorella di Giuseppina e zia di Francesca Privitera |
In cerca
di lavoro
Quando mi laureai,
andai a Roma, da mio Padre; egli mi presentò un gruppetto di Bengasini,
in un Ufficio del Ministero degli Esteri. Fra quei signori mi sentii a
disagio, loro seduti a semicerchio e io sola, di fronte. Mi guardavano
senza fiatare. Quando finalmente mi accommiatai ed ero già in un
corridoio in penombra, sentii una voce che con fervore di carità mi
disse: “Vada, vada da Paola al Ministero dei Beni Culturali”. Capii che
si trattava del papà di Paola Hoffmann, il quale mi aveva osservata per
tutto il tempo in quel modo descritto dalla figlia sul libro “La
mia Libia”.
Ero stata compagna
di asilo e di alcune classi elementari di Paoletta. Certamente il suo
papà aveva in mente di aiutarmi ed io lo ringrazio e gli sono
riconoscente, ora che si trova in Paradiso. Il dott. Hoffmann e mio
padre erano Bengasini di vecchia data ed erano rimasti a Bengasi fino
all’ultimo sul teatro delle invasioni inglesi e dell’Asse. Se mi avesse
detto: “L’accompagno da Paola”, si sarebbe mosso un ingranaggio per il
posto di insegnante, per la casa, per la riunione della famiglia. Ero
appena laureata, quindi senza un soldo. Quel Ministero in quel momento
mi sembrò nell’ombra come quel corridoio, lontano, difficile da trovare
... mi scoraggiai, sicuramente ero depressa, anche se non si vedeva e
se non lo sapevo. All’indomani mi capitarono strani avvenimenti che mi
impedirono di afferrare quella mano che mi era stata tesa, tornai da
mia Madre. Il travaglio per trovare la luce fu più lungo. Per
acquistare punteggio iniziai ad insegnare in Abruzzo, a Bisenti
(Teramo), fra brava gente. Furono tre anni di sacrifici, lontano dai
miei genitori, che rivedevo per Natale e a Giugno. Poi continuai in
provincia di Siracusa.
La Madre
Ella nacque in
Acireale il 13 gennaio1895 e morì a Giarre il 23 luglio1974. Aveva lo
sguardo vellutato medio-orientale che diventava molto severo quando ci
riprendeva. Le sue pupille erano castane, le ciglia e le sopracciglia
scurissime, così gli occhi sembravano neri. Non per niente il suo
cognome (Zappalà) è di etimologia araba, significa: “Amato da Dio”. Era
di media statura e molto proporzionata, di pelle ambrata, non usava
trucco, morbide onde naturali di capelli neri, di media lunghezza, le
incorniciavano il viso. Prima di sposare, aveva le trecce folte, che
scendevano fino ai fianchi. Con la sua voce intonata, quando aveva il
tempo e l’estro, cantava le canzoni della sua epoca: Partono
i bastimenti, O sole mio, O marinariello, Torna a
Surriento, Il Piave, le canzoni di chiesa e le romanze delle
opere liriche più conosciute: Traviata, Lucia di Lammermoor,
La Gioconda, ecc. Mi diede le prime
nozioni di pianoforte che aveva imparato da suo nonno (il quale ne
aveva due, uno orizzontale e uno verticale) e nozioni di taglio e
ricamo. Durante l’anno di profuga a Parma, si perfezionò con un corso
di taglio geometrico.
“In quale boutique compri i vestiti?”.
“Me li cuce mia Madre” rispondevo alle
colleghe d’Università. Aveva
studiato dalle Suore di Maria Ausiliatrice. Per non so quanti anni vinse sempre il
primo premio nelle gare del Catechismo.
Mia Madre è stata giudicata dalle
persone che guardavano da fuori,
come persona rigida nei riguardi dei
figli. Fu invece dignitosa custode
della libertà dello spirito, non come certe mamme che dicono ai figli:
“Sposati quel ricco e ci mettiamo
tutti a posto”. Ci ha tirato “fuori dal pelago alla riva”, fu eroica
anche con se stessa: basti pensare che si rimise a insegnare alla
soglia dei cinquant’anni. Prima la scuola serale (l’autobus non faceva
servizio a sera inoltrata, così pernottava in casa di un’insegnante del
luogo e la mattina ritornava a casa) poi la scuola regolare. Per le
coincidenze degli autobus che la conducevano nella città sulla cima di
un monte, usciva da casa nelle ore antelucane. Mi raccontava di
discendenza nobiliare, ma con la povertà sopravvenuta lentamente, di
cui ho parlato, si dispersero i rami dell’albero genealogico della
nobiltà, e si dileguarono le frequentazioni altolocate. So di certo del
privilegio delle Arti Maggiori equiparate alle classi nobili, come si
legge nella storia di Firenze. Il 2 ottobre 1949 mia Mamma e i miei zii
vendettero l’ultimo resto di un passato di benessere industriale, una
scuderia ereditata dalla mia nonna Isabella. So con certezza che il mio
bisnonno Angelo Toscano apparteneva alla Compagnia dei Bianchi,
composta da soli nobili, che disimpegnava la lodevole opera di
confortare i condannati a morte. Di questa Compagnia, si parla nella
Memoria per la libertà delle manifatture di seta nel Regno di Sicilia -
9 marzo 1781 - di Vanni Carlo. Di questa ci parla Dacia Maraini nel suo
libro La lunga vita di Marianna Ucria.
Il
bisnonno Angelo aveva il diritto di presenziare fra i Bianchi nelle
assemblee in Municipio, nelle funzioni in
Chiesa e nelle processio ni in
onore di Santa Venera, Patrona della città. So che mio zio Teodoro
Toscano,
figlio di Angelo, a Parma, mi conduceva a visitare gli
ammalati
terminali, certamente per antica eredità morale-familiare.
Nuovi
ricordi
Quando, alla ditta
Zappalà fu assegnata la prima fornitura dello spaccio della caserma
Moccagatta la Mamma per non essere sola, andò con me per la stipula del
contratto; era simpatica e sotto i quarant’anni. Il Generale De Guidi,
molto cortese, accortosi che Mamma in sua presenza non sapeva da che
parte cominciare Le andò incontro con riguardo, la tolse dal disagio,
alzandosi dalla sua poltrona, porgendole la sedia. Qualche tempo dopo
disse a una persona, che si aspettava un altro tipo di signora. Che
cosa volesse dire non saprei. Forse una dal piglio manageriale? O dai
modi spregiudicati?
 |
|
Al
fonduk dei cammelli. Francesca, Cosimo ed
il sig. Mansur.
|
Quando frequentai le
elementari, la Mamma mi seguiva nei compiti, mi spianava la strada
dalle difficoltà. Mi accorsi di averle frequentate soltanto per il
fatto che primeggiai. Amai lo studio, le compagne e le maestre Cunsolo
e Maccagno e l’edificio della Scuola Comunale che rividi trasformato in
uffici amministrativi civili e militari, sotto il Governo del re Idris.
Dopo aver spiegato, la maestra Maria Maccagno, subito, faceva la
verifica per iscritto, io ero la prima a consegnare e a meritarmi
lodevole sul quaderno, sia in Italiano che in Aritmetica. Nelle scuole
superiori, vi era parzialità camuffata da selettività. A figli di
operai e commercianti ben preparati, capitò di completare gli studi
liceali in Italia. Una parte di alte cariche, civili e militari, si
diceva che fossero riservate per i discendenti di coloro che le avevano
insediate dopo la conquista della Libia.
La società bengasina
La città di Bengasi
progrediva nell’edilizia, nell’economia, nel commercio e ferveva il
lavoro in tutti i settori. La società di Bengasi andava
complessivamente d’accordo anche se infiorata da tanti modi di dire.
Gli Arabi metropolitani dicevano che i Siciliani erano mangiasapone;
gli Italiani del Nord, dicevano che i Siciliani erano i
beduini d’Italia; alcuni dimenticavano di trovarsi nelle
Colonie per lo stipendio raddoppiato; le alte classi impiegatizie non
gradivano le colf indigene (mabrucke); queste dovevano essere friulane;
i diplomati e laureati, dimenticavano che se non erano disoccupati in
Italia, lo dovevano ai soldati che avevano conquistato la Libia. A
Bengasi vi erano Italiani del profondo sud della Sicilia e della
Liguria, i cui antenati si erano stabiliti in Tunisia tra il 1700 e il
1800; questi Italiani, si erano trasferiti in Cirenaica dopo la guerra
Italo-Turca, per sentimento patriottico e permeavano i quartieri
bengasini in cui vivevano, con l’acquisito modo di vivere improntato ai
tre principii della Rivoluzione Francese, cioè: Liberté, Fraternité,
Egalité. A
mia Madre non sembrava vera questa nuova realtà, tanto che non ne volle sapere di
comprare il palazzo del nonno che era in vendita, come avrebbe desiderato
la nonna Isabella. Nel
corso di 30 anni il Governo Italiano s’industriò per creare la possibilità di
socializzazione fra Italiani e Arabi; ma in realtà molti Italiani non avevano
una informazione adeguata sul popolo che avevano a fianco. Un giorno, passando per
il Corso Italia, vidi un obelisco; mi fu detto da un signore che era
dedicato al silfio, simbolo della Cirenaica.
Confessai di non sapere cosa fosse, perché a scuola non mi avevano dato
notizie relative alla storia della terra in cui vivevo. Ogni Paese ha i
suoi santi, i suoi poeti, i suoi eroi, la sua civiltà. L’Arabo captava
con la sua sensibilità l’albagia di qualche Italiano nel suoi
confronti. I nostri operai abitavano in civili abitazioni con i servizi
igienici e l’
infrastrutture
nel quartiere: luce, acqua, strade asfaltate. Un giorno andando alla
scoperta della mia città con la biciclettina mi accorsi che i negri
molto poveri abitavano nella bidonville dei Sahabri, ubicata nei pressi
del mare, pensai alle lamiere infuocate dal caldo torrido e mi proposi
che l’avrei fatta sostituire da casette in muratura, quando sarei stata
grande, come tribuna della plebe emula dei Gracchi! Gli Arabi cirenaici
avevano conservato la purezza razziale delle tribù arabe Bani Sulai del
XII secolo che li autorizzava a chiamarsi Saadi cioè
nobili; gli Italiani li chiamavano indigeni; gli Arabi interpretavano
questa parola con un significato spregiativo, come se di loro si
facesse di tutta l’erba un fascio e si rifugiavano nel rimpianto del
Governo Turco. Nel 1919 l’Italia democratica e liberale spontaneamente
elargì alla Tripolitania e alla Cirenaica gli statuti e gli ordinamenti
politico amministrativi, così diede alle sue colonie una struttura
nuova che le rendeva autonome e chiamava i Libici a collaborare con gli
Italiani nel governo e nelle pubbliche amministrazioni. A latere della
cittadinanza italiana metropolitana, venne istituita per i nativi e per
i resi denti, la cittadinanza
libica che assicurò la perfetta eguaglianza di tutti dinanzi alla legge, l’inviolabilità
del domicilio, la libertà di stampa e di riunione, il diritto elettorale
attivo e passivo, il diritto di petizione al parlamento nazionale, il diritto di
concorrere a cariche pubbliche civili e militari, il libero esercizio
professionale nel territorio nazionale e il rispetto degli statuti personali
e successori e delle consuetudini locali.
Quando Mussolini
visitò Bengasi, si fece stimare dagli Arabi tanto che la mia vicina
Selma mi disse tutta contenta: “Adesso Arabi e Italiani suà
suà” (cioè uguali). La guerra del 1940 non permise che si
formassero durevoli unità sociali, ma, nell’insieme ognuno dava quel
che aveva di meglio e il prodotto della fusione delle civiltà di Arabi,
Italiani, Maltesi, Ciprioti, Inglesi, Greci, Ebrei, Egiziani, Turchi,
Armeni, Indiani, Etiopici, Sudanesi, consisteva e consiste, ancor oggi,
in una specie di antico e sempre rinnovantesi ellenismo.
Certe volte mi
domando: “L’amicizia laggiù c’era? Era più vera di quella che c’è in
Italia? O fu frutto della mia fantasia di tredicenne?”.
Educazione
scolastica e familiare
Sin da quando si
sbarca, c’è gran sentimento di ospitalità: questa potrebbe essere
sorella dell’amore verso il prossimo. Un giorno la maestra disse a
tutta la classe : “Le Suore hanno aperto la Scuola Elementare, chi
vuole andare me lo dica”. Mia Madre mi diede il benestare. Nella mia
immaturità, credetti di fare una buona azione alla Maestra, come quando
davo il contributo per la Croce Rossa. Non immaginai nemmeno
lontanamente che non avrei più rivisto la Maestra e le compagne amate.
Quel consenso mi fu dato in un momento scelto male da me poiché lo
avevo chiesto alla Mamma, dopo che aveva lavorato in fabbrica ed era in
cucina,
sul punto di calare la pasta. Allora ero una bambina e non sapevo che quando si chiede un
parere, bisogna scegliere il momento opportuno per riflettere e
ragionare sull’argomento. In
realtà per me quel cambio fu un trauma. Mi mancarono le compagne con le quali
eravamo andate di pari passo sin dall’asilo. Mi mancò la maestra
Maccagno con le sue battute, i suoi proverbi, la sua incredibile
imparzialità. A
proposito di Lei, ricordo di una compagna che durante il lavoro in classe mi aveva
chiesto di copiare, io avevo acconsentito, ma quella non voleva copiare, ma
giocare e non faceva lavorare né me né
quelle delle file attorno a noi. La
Maccagno, che seguiva l’andamento
della classe, l’apostrofò tuonando, con
un appellativo che si riferì al
suo cognome e che non ripeto.
 |
|
Francesca
e Cosimo a cavallo accompagnati
dal fiero Mahamud Scemsa (al centro).
|
Gli anni di profugato in Italia
furono duri, tranne l’Università, perché a Catania ero fuori dal tiro
di quelli che volevano fare di me un’emarginata e un’oscura massaia
carica di rimpianti, come mia nonna. “Vi è morto il padre” dicevano
dei parenti, volendo sottintendere che se non fosse stato ucciso il
capo del Governo di allora, sarebbero finiti i nostri affanni. Nel mio
vivere nel mondo dell’iperuranio, la prima volta, per capire questa
battuta feroce, mi scervellai. E pensare che costoro ai tempi delle
vacche grasse, avevano ampliamente ricevuto benefici da noi; essi si
sentirono assolutamente estranei al resoconto delle nostre sventure di
guerra. Sapevano bene che i miei genitori erano andati avanti con il
loro capitale, altro che: “Vi è morto il padre!”.
Essi mi educarono al pudore,
all’educazione del cuore, ad essere cattolica osservante. “Mamma, la vicina di casa mi ha detto
che fa l’amore. Come si fa l’amore?”.
“Sai, figlia mia,
san Francesco dormiva sulla terra nuda, si metteva il cilicio e per
cuscino aveva una pietra”. Papà la domenica mattina mi conduceva a
sentire la musica della banda, che si esibiva sul palco nei pressi
delle colonne della lupa di Roma e del leone di San Marco; l’ascoltavo
rapita. Egli mi rese indimenticabili Invito alla danza
di Weber, Poeta e contadino di Suppé ed altri
pezzi. Immancabilmente alla fine dell’ascolto, mi offriva i wafers o
una cialda ripiena di un tuorlo, caro Papà, mi insegnò a disprezzare i
vigliacchi, mi insegnò la pazienza, la speranza, a camminare da sola
nel duro cammino della vita, le cose elevate e a sopportare il dolore.
Quando piagnucolavo per qualche ammaccatura mi diceva: “Non si dice ahi
!”.
Amici di
famiglia
Nel 1957 mi recai in
luoghi ricchi di memorie, della mia primissima infanzia. Avevamo un
piccolo châlet, ai Sahabri, e
ricordo che lungo il percorso dalla spiaggia alla strada eravamo un
drappello: l’avvocato Nolfo e signora Tina, madrina della mia sorellina
Silvia, i miei genitori, i miei due zii e una nidiata di bambini
composta da quattro fratellini e una cuginetta, tutti sotto i cinque
anni. La signora Nolfo è stata per me, che avevo le nonne in Italia,
come una giovanissima nonna. Per alleggerire il peso della figliolanza
a mia Madre, lei che non aveva figli, mi prendeva in braccio e mi
portava a casa sua. Con le sue premure mi esternava il suo affetto. Con
i riccioli d’oro e gli occhi verde-azzurri, ero la figlioletta
bambolina che ogni madre vorrebbe: tranquilla e bellissima. Ben presto
se ne andò dal nostro quartiere Sidi Draui al viale Giacomo De Martino,
dove era sorto un quartiere di villini per famiglie di impiegati del
Governo italiano della Cirenaica, e poi ancora più lontano a Barce,
dove suo marito occupò un’importante carica questa signora, sento ancora la
sua melodiosa parlata trevisana. Mi ricordo di un basco di lana
d’angora che lei mi regalò, lo indossai una volta sola, perché alla
fine delle lezioni non lo trovai nell’attaccapanni della scuola dove
l’avevo lasciato fiduciosamente. Mi dispiacqui tanto, prima perché me
lo aveva regalato lei, poi così bianco, così morbido, mi era sembrato
prezioso. Altre signore, amiche di mia madre, a cui a Bengasi ho voluto
molto bene come zie, sono state: Genoveffa Chiarenza di Moglia il cui
marito, signor Vincenzo, morì quasi subito dopo il rientro in Italia;
qualche volta andai al mare con i signori Chiarenza, perché i miei
genitori erano impegnatissimi con quella benedetta fabbrica,
specialmente d’estate; Gelsomina Massimi Delfino: questa signora,
qualche anno prima dello scoppio della guerra del 1941, era venuta ad
abitare in una propria villa, sul confine della nostra casa alla
Giuliana. Mi ricordo di una sala semicircolare della villa, con grandi
finestre panoramiche e di aver conversato con lei, tutta compita, nella
cerimonia del thè, con tovaglia preziosamente ricamata e dolci. Quando
mi vedeva, in quelle poche estati che precedettero l’entrata in guerra
dell’Italia nel 1941, si compiaceva, con mia Madre, sul mio fisico che
si andava sviluppando e pronosticava armoniose proporzioni. Con i
coniugi Delfino viveva il nipote Nik, liceale, ex alunno lasalliano Diana, pastore tedesco. Ci
rintracciò in Sicilia, per mezzo del maestro Bottino e ci scrisse per
lunghi anni da Tripoli, fino al 1970, al suo rientro a Roma. Per
l’ultima volta ebbi il piacere di rivederla a Roma dopo trent’anni, ove
mi recai per l’Anno Santo, nel 1975. Mi raccontò delle sofferenze
patite a causa della politica di Tripoli. Prima della guerra era alta,
robusta, rosea; la riconobbi quasi soltanto dalla parlata ternana.
Rispetto alle mie coetanee il mio gradevole aspetto fisico si prolunga
un po’ più nel tempo, ma lei mi vide cogli occhi del suo immutato
affetto,
come quando ero ancora in boccio. Le sue ultime parole per me, al
momento del commiato furono: Morì
qualche anno dopo a Roma, a causa di una caduta, entrando in ascensore.
Da
Tripoli mi aveva mandato due tappetini di Misurata, che custodisco
con particolare significato, e degli indumenti di lana, lavorata a
mano, per neonato. A Tripoli si era data all’insegnamento dell’Economia
Domestica. Il marito era un impiegato del Genio. Ho un terreno in
località marittima, qualche ciuffo di banani, di palme, gelsomini
d’Arabia, ibischi, ... ricostruiscono il giardinetto della mia casa in
Bengasi. Ogni volta che i vicini mi fanno trovare piante con le radici
al sole, automaticamente il mio cuore calpestato si rifugia al ricordo
dei vicini di un tempo, alle cortesie, alle farfalle negli occhi che la
signora Delfino aveva per me! Queste signore erano di grande elevatezza
d’animo; peccato averle perdute molto presto, erano la mia affinità
spirituale.
Compagne
d’infanzia
Ecco alcune delle
mie coetanee, compagne di giochi o di scuola, o di quartiere: Matilde
Ercolani, Ida Scaglione, Franca Cusimano, Giuseppina Cultrera,
Salvatrice Fidone, Marcella Magnani, Paola Hoffmann, Viviana Epifani,
Maria Tedesco, Miranda Bastita. Wanda (nata a Bengasi, da genitori di
Buia) era la più vicina di casa e, forse, al mio spirito; mi venne a
trovare qualche giorno prima della fuga, mi disse che trascorreva le
ore leggendo sotto l’ombra degli alberi come se invece di essere
sfollata, in quel luogo, fosse per villeggiare, non immaginando
l’apocalisse alla porta della sua e della mia vita. L’ho rintracciata
nel 1984, tramite Fratel Amedeo, che mi indirizzò al signor Pietro
Secco. Mi ha raccontato per telefono che strappata a quel paesaggio
idilliaco a causa della rotta di Tobruk, era stata per vari anni
ammalata, dopo il rientro in Italia; che insegnava, si è sposata, ha
una figlia e avrebbe piacere di rivedermi a Firenze; che non le è
rimasta nemmeno una foto della sua casa e che non ne vuol più sapere di
Bengasi. Le ho chiesto stupita: “Ma ti ricordi di me?”. “Sì, sì, la
fabbrica, via Sneidel, tu eri bionda con gli occhi azzurri!”. Wanda
aveva una dolce intonazione quando parlava e camminando sembrava non
poggiasse i piedi a terra. I suoi vestiti, ricchi di stoffa arricciata
in vita, ondeggiavano quando si muoveva e la facevano sembrare
leggiadra come una farfalla. Conosceva la nomenclatura di tutti i fiori
del giardinetto di piazza del Re. Era gioiosa e canterina, cresceva
molto in altezza e restava snella; abitava in un condominio di via
Sneidel, angolo viale Regina. In questo risiedevano anche le famiglie
Gulino, Lombardo, Avarino, e Angelo Formica, studente liceale, oriundo
di Vittoria, figlio di una ricamatrice, trattato con sussiego dalle
compagne perché suo padre era operaio. Ero complessata perché non
abitavo in un palazzo come lei. Invece ero privilegiata e non lo
sapevo, ecco perché. La mia casa in stile mediterraneo aveva fiori
coltivati in piena terra, negli spazi liberi attigui alla casa; le
stanze con finestre erano intercomunicanti e accessibili anche dal
cortile; aveva i vantaggi di una casa di campagna pur essendo nel
centro cittadino a pochi metri da viale Regina, al n° 12- 13. C’era la
possibilità di allevare un gattino, un cagnolino senza dover pensare
alla passeggiata igienica. Un lungo vialetto, dal cancello d’ingresso
al portone, la preservava dai rumori della strada. Confinava su tre
lati con altre case in stile mediterraneo, cioè dava la possibilità di
familiarizzare con le vicine arabe, mediante le terrazze. Era stata
ristrutturata, ciò la rendeva maggiormente luminosa, ventilata, fresca
d’estate e calda d’inverno.
 |
|
Bengasi,
1930. Una giornata al mare dei Sahabry. In piedi: il Dott. Comm. F.
Nolfo, direttore amministrativo Ente Colonizzazione, amico di famiglia
e la Giuseppina Zappalà con l’ultima nata, Lidia. Seduti: Angelo
Privitera, con Silvia in braccio, mentre tira un orecchio a Cosimo; la
zia Venera, la cuginetta Elvira e Francesca
|
Mitica spiaggia
Oltre che ai Sahabry
mi recai alla Giuliana, luogo mitico, per noi ragazzi bengasini del
1941. I miei genitori, qualche anno prima dello scoppio della guerra,
avevano comprato 999 metri quadrati di terreno sabbioso, su
cui sorgeva una costruzione di cinque
vani, accessori e veranda, il tutto sul
viale Nobile Mansuero. La
costruzione non l’ho vista, forse era sepolta dalle dune formate dal vento, che ad ogni
primavera mio Padre faceva rimuovere, o forse non esisteva più perché
essendo stata requisita dalla milizia contraerea, era stata demolita
dalle bombe. Vicino
al nostro terreno, al tempo pre-bellico, si era attendato un nomade con la
famigliola, il quale gentilmente aveva chiesto l’uso dell’acqua e della
veranda; in cambio offrì la custodia. Aveva una figlioletta di nome
Jndìa, chiesi notizie di lei, ma invano; non so cosa darei per rivederla,
fra noi si era instaurato un legame di affetto familiare. Ricordo gli occhi
vellutati e giocosi di Jndìa, quando mi vedeva arrivare. Sulla destra della
costruzione, vi era un ciuffo di oleandri e un fico selvatico, sulla
sinistra, un gruppo di pini marittimi; quando li ho rivisti, erano irriconoscibili,
ridotti ad uno sparuto ciuffo di rami spogli, contorti, e spezzati
dal vento e dall’incuria. Al di là del nostro terreno di sabbia chiara,
vi era il viale, l’immenso arenile
e il mare. In questo spazio silenzioso, sconfinato, nella luce trasparente di un
mattino d’estate, ebbi la prima dichiarazione d’amore, inaspettata; nella mia
semplicità, esternai la mia meraviglia al
ragazzo:
“Ma io non ti conosco nemmeno di vista,
come mai dici di avere tutti
questi sentimenti per me?”.
Mi rispose di vedermi quando si
recava da suo padre che aveva un’industria
in quei paraggi (del quale mi presentò le credenziali per acquisire la mia
fiducia). Mi disse inoltre: “Io
invece ti conosco, sei la sorella del mio compagno Cosimo, ti vedo anche quando vieni
a trovarlo all’Istituto
La Salle”. Era
l’anno scolastico 1937-38. Poiché mi apparve bello e sincero,
alla mia gentilezza d’animo, sembrò male non credere a quello
scintillio di parole, simili a pietre preziose. Ma, a causa della mia
giovanissima età, a causa delle raccomandazioni di mia Madre e degli
insegnamenti di Suor Gabriella che mi aveva preparata alla prima
Comunione e Cresima da poco, a causa del mio carattere romantico e
della mia ingenuità, mi trovai a disagio, mi commossi, non seppi cosa
dire, risolsi il problema con una conversazione amichevole fatta di
progetti su cui concordammo, che mi diedero sincerità e fiducia, nel
senso che oltre ad avere l’affetto dei miei genitori avrei avuto anche
lui e il suo affetto nell’avvenire. Fummo generosi esclusivamente di leggiadri
propositi. Poi cominciò la scuola e l’inverno; le cause che ho detto, la
guerra del 1940 e la fuga del 1941 non permisero la normale crescita
della nostra adolescenza, la quale così morì assassinata.
Addio spazi
silenziosi e sconfinati, addio luci trasparenti, addio mare, addio
Giuliana!
La guerra e la fuga
sparsero le famiglie dei profughi di Libia nel mondo, specialmente
nell’Italia del Nord e in America, in Canadà e in Australia.
 |
 |
|
Bengasi. Corso Italia |
Bengasi. INA e Cassa di Risparmio |
I
bombardamenti
Pirandello, dice
nella novella I nostri Ricordi che la realtà, gli
individui, non sempre sono gli stessi; i luoghi e le cose non hanno più
quegli aspetti che con tanta dolcezza di affetti custodiamo nella
memoria. Così la filosofia di Eraclito studiata al Liceo: panta
rei (tutto scorre in un fluire incessante). Gli Inglesi
venivano a bombardare quasi tutti i giorni dalle sedici del pomeriggio
alle quattro del mattino. Fummo costretti a sfollare a Tocra, in un
panoramico castello turco, che era fuori dalla loro rotta, messo a
disposizione dal Governo Italiano di Bengasi, ad alcune famiglie di
impiegati governativi. Dai suoi spalti, in una terribile sera,
assistemmo ad un feroce bombardamento che si protrasse per molte ore
della notte. Vedemmo la mia adorata Bengasi, che avevo visto sorgere
nei suoi edifici, nei suoi viali, nel suo lungomare, nella sua
Cattedrale, che rosseggiava, a causa delle fiamme delle bombe
incendiarie lanciate sui depositi di carburante: sembrava l’incendio di
Troia descritto nell’Iliade; inoltre le bombe che cadevano a grappoli
dagli aerei e quelle lanciate dalle contraeree, con le loro traiettorie
disegnavano nel cielo della città un gioco di linee pirotecniche, di un
unico color rosso. Questo bombardamento ridusse il mio quartiere in un
ammasso di macerie.
 |
|
999
metri quadri di spiaggia dove era la casa che le bombe distrussero e la
sabbia seppellì.
|
Da una fila di case
polverizzate della via Sneidel, si poteva passare a piedi nella via
Nabbus. La mia
casa che era nella fila opposta, fu colpita da una bomba incendiaria, la quale
perforò il tetto e cadde su un tavolo di legno, su cui vi era una coperta
di lana. Si dedusse dal tavolo bruciacchiato, che vi era stato un principio
d’incendio, non propagatosi per via della coperta di lana. Questo
bombardamento diciamo “intimidatorio” precedette l’invasione della
città da parte degli Inglesi (6 febbraio 1941) e segnò l’abbandono
della città da parte nostra, poiché le autorità ci fecero fuggire prima
verso Tripoli e poi verso l’Italia. Un negoziante del soûq, diciassette
anni dopo, mi rimproverò dolcemente: “Voi vi siete messi al sicuro e ci
avete abbandonati”. Non risposi per non fare polemiche. Pensai: “Non vi
abbandonammo, piangemmo, fummo obbligati a lasciare il piatto caldo
sulla tavola apparecchiata e a lasciare la nostra casa, senza preavviso
e per sempre”. Poco prima dello scoppio della guerra, in un pomeriggio
d’autunno, la Mamma, aveva preparato col pozzetto il gelato e lo aveva
offerto agli ospiti, sotto i nostri pini. Vi era il geometra Morbidelli
Vittorio, con la moglie che era in attesa, e un ufficiale con la
famiglia, che ci intrattenne simpaticamente, con del genere comico in
dialetto palermitano. In quel tempo ormai lontano, la brezza ci portava
le canzoni dei ritrovi sul mare: Pizzo, Carletto, Mirabella. Ora, né
châlets, né cabine, né musica. Mio fratello ed io fummo invitati da
signori Arabi sotto una grande tenda alla spiaggia; appena entrata, la
sentii confortevole, piccoli mobili, il frigorifero, finestrelle
schermate, si camminava su un pavimento molto soffice, di tappeti,
sulla sabbia. Non ne avevo mai visitate prima, mi sembrò incantevole.
Alla Giuliana non vidi il monumento a Mario Bianchi; né il palmeto.
 |
|
Bengasi.
Francesca Privitera davanti all’Istituto De La Salle, dove studiò il
fratello Cosimo.
|
In quei paraggi, immensi
contenitori d’acciaio, di forma cilindrica, pieni di petrolio,
brillavano al sole con ghigno pio. Presso il pontile, non udii la nenia
struggente di una zummara, che ogni sera il vento portava chissà da
quale deserto. Non vidi gli idrovolanti, nell’idroscalo. Quel luogo era
spoglio della mia atmosfera ormai lontana. Non vidi il leone di Venezia
e la lupa di Roma, sulle colonne che adornavano il lungomare, non la
folla di gente per le strade; non c’era più logicamente, la banda
militare che diffondeva nella città l’allegria in ogni occasione: lo
sbarco dei soldati che andavano in Abissinia, la visita del Re, dei
principi di Piemonte, del generale Graziani, del duca d’Aosta, di
Mussolini; la banda bandeggiava, bandeggiava, noi bambini eravamo
felici. Cantavamo Noi ti daremo un altro regno e un altro Re.
Ci piaceva il motivo, non capivamo niente delle parole cattive della
canzone e di politica. Un giorno mi recai in un Ufficio presso le ex
Scuole Comunali Italiane. L’ufficiale Arabo che mi consegnò un
documento mi porse compito il suo biglietto da visita, con rammarico
non capii niente di quello che lessi, era scritto in Arabo e in
Inglese, non avevo studiato l’Arabo e come lingua straniera a scuola
avevo studiato il Francese! Pensai che questo mi stava capitando a
causa di una guerra assurda, una
evacuazione assurda, politici assurdi che non si occuparono del nostro
immediato ritorno a casa. Mi sentii una naufraga, quel cartoncino che
voleva essere un segno di ospitalità, per me fu come un approdo di
scogli irti, con le sue parole incomprensibili.
 |
 |
|
Bengasi.
L’Istituto De La Salle imbandierato nel giorno
dell’inaugurazione.
|
Cirene.
Le terme (piscina).
|
Il Padre
Mio Padre, Angelo
Privitera, nacque ad Acireale il 17 aprile 1889 e morì ad Acireale il
29 novembre 1964. Privitera deriva dal greco e significa proveniente da
Thera. Coloro che italianizzarono i cognomi arabi e bizantini furono
maestri nell’arte di sgorbiarli. Era figlio di un costruttore edile e
proprietario. Era nato nel palazzo a due piani dei suoi avi sul Corso
Umberto nei pressi del giardino comunale. In giovanissima età era
emigrato da solo a
Malta, a causa della legge del 1887 e del protezionismo industriale che travolse l’economia
e la vita dell’Italia Meridionale e che spinse milioni di Italiani all’estero,
tra la fine dell’800 e i primi del 900. Fu presto orfano ma, per
fortuna, non cessò di frequentare il nonno materno, Angelo, che fu di
mente lucida oltre i 90 anni. Di questo nonno, professore di lettere,
valido pianista e cattolico osservante, subì l’influenza morale, civica
e culturale. Mio Padre fu tra i primi italiani che popolarono la
Cirenaica, in seguito alla guerra italo-turca del 1911-12: erano
italiani di un’onestà che ora sembra di fiaba. Quando sbarcavano
individui clandestini e privi di contratto di lavoro, venivano
reimbarcati con la stessa nave con cui erano arrivati. Ciò si attuava
per evitare il formarsi di una società discendente da avventurieri e
costituire una società per bene in cui Libici e Italiani si
rispettassero e lavorassero. Infatti a Bengasi non vi era delinquenza e
il carcere era pressoché vuoto. Per noi ragazzi di Bengasi del ‘41, fu
difficile l’inserimento nella società dell’Italia, perché facevamo
parte e stavamo formando una società migliore, che respirava aria nuova
prima ancora di nascere. Mio fratello ed io, tanto per fare un esempio,
trovammo nei nuovi conoscenti, l’abitudine a infiorare la conversazione
di piccole bugie, che loro definivano bugie di comodo. Alcuni libici
del Gebel cirenaico erano legati al Governo turco ed esercitavano la
guerriglia: vennero appellati ribelli dall’Italia. Guardando l’altra
faccia della medaglia, erano patrioti, con a capo Omar el Muktar.
 |
|
1911.
Angelo Privitera (indicato da una freccia, in piedi, di profilo, quasi
al centro della foto), padre della scrittrice, durante la guerra di
Libia.
|
Questi sin dal 1923 fu comandante
della guerriglia che venne alimentata dal contrabbando di armi e
viveri, attraverso il confine egiziano. Ultrasessantenne, capo zavia,
era energico e battagliero, religioso, xenofobo, astutissimo,
imperterrito e inafferrabile. La sua tattica era fatta di clausole
stipulate con i delegati del Governo Italiano e non ottemperate, (es.
la mancata consegna delle armi) di convegni fatti di tortuose
discussioni, dilazioni, tregue interrotte, attacchi proditori ad
autocolonne militari in marcia, ad autocolonne di viveri, ad oasi
presidiate. Egli creò una situazione logorante, che impediva la
completa occupazione italiana della Libia. Finché l’11 settembre 1931
fu catturato, giudicato e condannato a morte. Con lui si spense anche
la guerriglia. Nel gennaio 1931, un poderoso corpo di spedizione con a
capo il generale Rodolfo Graziani e Amedeo di Savoia Duca d’Aosta,
comandante dei meharisti, dopo aver attraversato in quaranta giorni di
marce estenuanti e strenue lotte l’immenso serir Calanscio, occupò
l’oasi di Cufra. Così, pacificato il territorio, l’Italia si dedicò
all’assetto giuridico-politico e amministrativo della Libia. I miei
genitori non andarono a vedere l’esecuzione di questo eroe leggendario.
I ribelli, man mano che si restrinse il cerchio, soffrirono la fame e
mio Padre mi raccontava, con pietà, di averne visto a terra, con la
pancia squarciata, piena di spine, di cui si erano cibati, lungo il
cammino montuoso e la pianura desertica, nel tentativo estremo di
avvicinarsi alla città e di abbandonare l’ormai inutile sentimento
patriottico in cerca di lavoro e di nuove speranze. Egli mi raccontava
dei morti per la pestilenza, dei bambini orfanelli che è meglio
tralasciare, ma che fanno meditare sulle guerre in nome del posto al
sole e delle grandeurs. Egli fu tra i soccorritori (incaricati dal
Governo Italiano) che portarono viveri, medicine, oggetti di prima
necessitàa tutti coloro che erano in stato di bisogno. Papà sostenne un
esame di Arabo con S. E. Moreno, professore presso l’Istituto di Lingue
Orientali di Napoli. Egli raccontava che infine, il professore gli
disse: “Si accomodi, Lei ne sa più di me”. Si dice: la
pratica val più della grammatica. Il professore sapeva la
lingua classica. Lui aveva incrociato in lungo e largo sin dalla prima
giovinezza il Mediterraneo, da Malta alla Grecia, e fu accettato il suo
Arabo locale e commerciale, non letterario. In un suo certificato di
servizio del 31 gennaio 1923 leggo: “Conosce discretamente l’Arabo e
l’Inglese”. Firmato: Commissario Gravagno.
 |
|
Bengasi.
Mausoleo di Omar el
Muktar.
|
Un titolo valido fu la medaglia al
merito, nella guerra Italo-Turca. Frequentò a Roma corsi di
aggiornamento. Così egli iniziò a far parte degli impiegati di Stato
presso il Governo di Bengasi. S. E. Moreno aveva grande stima di mio
Padre e gli propose di andare in Africa Orientale al suo seguito; già
era in atto l’organizzazione dell’Impero. Ma Papà, prima di sposarsi,
aveva comprato la casa di abitazione e la Mamma aveva avviato la
fabbrica, con attiguo deposito per le merci: casse, bottiglie, sacchi
di zucchero, bombole, essenze per le aranciate e gli sciroppi,
targhette, ecc. ecc. così non accettò suo malgrado - i figli erano
tutti piccoli - e decisero di rimanere in Libia. Trent’anni dopo, nel
1940, era di nuovo sotto le armi, all’età di 54 anni. Quando poteva,
tra un bombardamento e un altro, (ne furono contati 160, spesso a
ondate successive) con una squadra di nostri operai, che lui non aveva
licenziato e pagava anche se non c’era più
lavoro, andava, di sua spontanea
volontà, a sbarrare le porte scardinate dallo spostamento d’aria delle
case disabitate dei
vicini e specialmente di quelle della via Sneidel, dove avevamo
l’abitazione e la fabbrica, senza distinzione di nazionalità o di
religione. Mio Padre aveva ipotizzato una guerra di assedio e aveva
fatto tante scorte di viveri. Le navi mercantili non arrivavano più,
nei negozi mancava lo zucchero; venivano le massaie arabe a piangere a
casa mia, perché senza lo zucchero, fondamentale per la loro usanza di
consumare largamente il thè, non potevano lavorare. Per gli operai
arabi il thè è come il vino per i lavoratori italiani. Il primo lo
preparano molto forte, il secondo meno concentrato, il terzo leggero.
Nel deposito vi erano sacchi di zucchero dal pavimento al tetto (ultimi
sacchi svincolati da me, alla Dogana) e prima di lasciare la mia casa,
alla fine di gennaio del 1941, quanti pacchetti di zucchero regalai! Le
massaie arabe mi ringraziavano con voce commossa e mi dicevano: “Mafisc
scei, mafisc forsa” (Senza il tè, non c’è forza, per
lavorare!). Papà continuò dopo di me la mia opera benefica. Così Papà
diede soccorso alle genti di Bengasi, non più per conto del Governo
Italiano, come aveva fatto nel 1911, ma per conto personale. Nella
guerra del 1940, diede fondo a poco a poco alle scorte della famiglia.
Durante il corso di questa, diceva: “Quelli che non hanno mai avuto
spirito pionieristico se ne sono andati con tutta calma e hanno venduto
fino i manici della scopa”. Nell’aprile del 1941 ai Tedeschi era nota
la presenza a Bengasi di parecchie migliaia di civili italiani e arabi
metropolitani, ma Rommel non volle considerare le ragioni umanitarie,
mise in atto l’azione di assalto e distruzione della città. I siluri
lanciati dalle navi attraversavano gli obiettivi come se fossero pareti
di carta, saltarono le santabarbare delle navi da guerra ancorate nel
porto e i depositi di carburante delle caserme, furono visti marinai
nel porto bruciare vivi; fece lanciare dagli stukas in picchiata bombe
dirompenti, munite di speciale paracadute. La pioggia infernale, spinta
dal vento, andò su zone della Croce Rossa o in quelle densamente
abitate da civili, fu un massacro, falciò i civili e furonovisti gli
arti dei militari smembrati dalle bombe. Distrusse edifici e rase al
suolo quelli traballanti. Per due giorni si oscurò la luce del sole.
Mio Padre, a causa di uno spostamento d’aria, volò contro un muro,
sbattendo violentemente la testa e si risvegliò dal colpo dopo dodici
ore. Fu un miracolo se camminò e ragionò ancora per ventitrè anni. Dopo
tutto ciò i Tedeschi, con reparti italiani, entrarono a Bengasi dai
Sahabri, il 4 aprile 1941, aprendosi la strada da Agedabia. Gli Inglesi
si dileguarono verso Derna. La città, ridotta ad un cumulo di macerie e
profondi crateri, mutilata e rassegnata a ricevere altri colpi, tra
attacchi e contrattacchi fu conquistata dagli Inglesi una seconda volta
il 24 dicembre 1941 e definitivamente il 20 novembre 1942, divenendo in
seguito una importante base aeronavale per trasporti anglo-americani,
verso il Medio-Oriente. Quando cadde il fronte dell’Africa
Settentrionale, mio Padre, dopo essere rimasto miracolosamente vivo,
fuggì con altri militari verso l’Italia, per non arrendersi e per non
cadere prigioniero. Partì dall’aeroporto di Benina con uno stormo di
sette aerei militari che furono mitragliati in volo dagli Inglesi,
tanto che di questi ne arrivarono soltanto tre a Castelvetrano. La mia
famiglia si ricongiunse, con la venuta di mio Padre, a Parma. Finito
l’anno scolastico ci trasferimmo in Sicilia. I miei zii Venera e
Francesco, con i tre cuginetti, fuggirono da Barce per raggiungere
l’aeroporto. Sembra che uno degli autisti, per impadronirsi dei loro
bauli e del carico di valore dell’Impresa Fontana, sulla strada di
Barce, abbia staccato il camion dal rimorchio, dove erano stati
sistemati Elviruccia, Isabella e Gianni, rispettivamente di 10, 5 e 4
anni, così i miei zii che avevano trovato posto nella cabina di guida,
arrivarono a Bengasi, ma senza figli. Questi si recarono a piedi presso
una famiglia di coloni, al villaggio Oberdan, dove furono rifocillati e
accolti con affetto, comunicarono al Comando Federale come erano
rimasti soli. In seguito a preghiera di mia Madre, il cugino medico
Angelo Toscano trasmise lo stesso comunicato alla Croce Rossa, al
fratello sacerdote missionario, Padre Pino Toscano. La notizia fu
stampata sulgiornale di Tripoli, su quello dei Saveriani e fu predicata
nelle chiese d’Italia. Mia zia, la quale era rimpatriata in precedenza
con mio Padre, trovandosi alla Santa Messa, sentì il sacerdote che
sull’altare parlava del suo dramma e svenne dentro la Chiesa,
provocando un indescrivibile parapiglia. Dopo alterne vicende i bambini
rimpatriaronocon il padre che per cercarli era andato fino a Tripoli e
per riprenderliera ritornato a piedi, attraverso i boschi del Gebel,
fino ad Oberdan, perché il territorio era invaso dagli Inglesi che lo
avrebbero catturato. Erano trascorsi quattro mesi, simili a un secolo
per noi parenti. Lo zio era con la barba incolta, lacero e scarnito, la
zia era così sotto schock che non li riconobbe e disse loro:“Ho perso i
miei figli, sapete dove sono?”. Così anche la loro famiglia si
ricompose ad Altamura. Della mia casa mi è rimasto qualche oggetto
portato da mio Padre, e che era servito per imbandire la tavola al
cugino di Parma, medico, e a quattro suoi parenti d’acquisto, venuti da
Bengasi di passaggio,nella stessa autocolonna di marcia per il fronte
di Tobruk; qualche documento, qualche album di foto, un cuscino con le
trecce della sua amatissima moglie. Rimasero nel cassetto del comò le
foto dell’Asilo e delle Elementari e, nella libreria, la Scala d’Oro e
i libri di studio. Rivedo mio Padre negli ultimi giorni, seduto, mentre
con la mente andava alla sua giovinezza romantica, alla sua Cirenaica,
poi ripetevafra sé: “Trent’anni di Colonia! Trent’anni di Colonia!”.Io
mi struggevo perché non potevo fare niente per Lui. Il signor BakkarLenghi, interpretando
il movimento della fiammadel suo accendino, rivolta verso la sponda
libica, come un oracolo,mi predisse nell’ultimo mio viaggio nel 1960,
che un giorno sarei ritornata a
Bengasi.Sono passati 35 anni ma questo non si è avverato.Avrei gradito
rivedere le care famiglie dei miei operai. Quando dabambina venivo in
Italia, i pensieri più importanti per me erano i regali per loro; al
momento cruciale, risolvevano i miei problemi.Loro che possiedono un
bagaglio culturale, mi aprirono una finestrinasulla vita, con le favole
di Esopo, con i racconti sull’arte Medio-Orientale e le descrizioni
delle ineguagliabili Moschee del Cairo, chepoi ho risvegliato come
ricordi indelebili, nei miei studi classici. Poichéla mia infanzia
trascorse lontana dalle nonne, queste famiglie mifecero da
vice-nonne.Le apprensioni, intorno al nostro viaggio, dei “cari
parenti”, si rivelarono infondate. Gli Australiani, soldati più temuti
dell’esercito inglese, si eranocongedati da Papà con:“Good
bye, my Friend!”. E gli Arabi Cirenaici lo portarono in
trionfo.
 |
 |
|
Bengasi,
1941. Da sinistra: Angelo Toscano, Tenente
Medico, cugino di Francesca
Privitera; Francesca; la madre Giuseppa
Zappalà con il cagnolino Alidoro; il
padre Angelo.
|
Bengasi 1940. In primo piano,
da sinistra: Angelo Privitera con la moglie Giuseppa Zappalà e la
figlia Francesca; in secondo piano: Angelo Toscano (cugino),
Sincero Bresciani, Arcero Gentili (cognato di Angelo).
|
La fine di
un sogno
Purtroppo in quella
guerra del 1940, nel conseguente cataclisma abbattutosi su di noi e con
quella fuga senza preavviso si dissolsero come in un rogo casa,
amicizie, cibi indigeni, merci, fabbrica, risparmi, rendite, avvenire
sicuro, immagini, atmosfere.Finì un contesto sociale, una vita
irripetibile, nel bene e non.Rimase associata al ricordo della nostra
sala da pranzo, la visita di cinque ufficiali medici, uno cugino dei
miei genitori, gli altri parenti d’acquisto del cugino, fra cui Arcero
Gentili e Sincero Bresciani di Casina (Reggio Emilia). Mia Madre, già
terrorizzata a causa dei bombardamenti continui e dalla notizia della
disfatta del fronte di Tobruk,
quando li vide esclamò:
“Chi vi porta qui, non sapete che c’è l’invasione in corso da parte
degli inglesi?”. I miei genitori, che erano signori e ospitali con
tutti, a maggior ragione
lo furono con questi giovani destinati al fronte. La Mamma, che non si
scoraggiava dinanzi al lavoro, si prodigò in specialità regionali
cirenaiche, presentate su piatti d’argento di artigianato libico:
spaghetti al sugo di pomodori; pesce di fetta, cernia di scoglio,
dentice, insalata di lattughine, acciughe, olive, capperi, vini di
Pachino e di Vittoria, grandi dolcissimi, morbidi datteri, lucidi come
ambra, appena colti; caffè autentico.
“È caffè, caffè!”
loro dicevano. Era il caffè delle scorte di famiglia, fatte dal
sant’uomo di mio Padre! Fu bello per noi trascorrere momenti lieti in
compagnia di persone colte e distinte, illudendoci di ignorare la
guerra in atto. Fu bello per loro ritrovare la loro casa, nella mia
casa.
Uno degli ufficiali assomigliava a John Wayne. Egli, ispirato dal mio
candore, mi cantò una canzone, dove la fanciulla viene paragonata alla
musica, alla voce del mare, all’azzurro ciel, alla fiamma che dà la
vita! La sacca di Tobruk del 1941 non permise un secondo madrigale! La
politica internazionale pose sul trono di Libia un re mistico, l’emiro
Idriss della confraternita dei Senussi, con sede a Giarabub, dove la
vita si svolgeva nel più rigido islamismo. Dal 1941 in poi, in attesa
del visto che non ci fu, oltre allo studio mi dedicai ad attività
collaterali, musica, pittura e ricamo che attutirono il colpo per
l’abbandono della nostra casa, dell’azienda, degli averi, degli
affetti. Certe volte mi domando: “Quest’intaglio, questo quadro, questo
spartito l’ho ricamato, l’ho dipinto, l’ho studiato io?”. Il tempo
passa e uno non se n’avvede, quando si dedica al lavoro che è la fonte
migliore della serenità, come aveva scritto mia Madre molto tempo prima
che io nascessi. Rimase nell’ufficio un quadro originale per quel
tempo, perché trattava il tema dell’aviazione e non la tradizionale
natura morta o il ritratto. Chi lo guardava, vedeva una coppia di aerei
in volo, nell’atmosfera di un mattino di primavera. Vedeva fusoliere,
eliche argentee, ruotanti vorticosamente, immerse nei colori dell’aria.
Colori tenui e luci, si ritrovavano riflessi e dilatati su tutta la
tela di cangiante seta moiré. Il quadro era opera del maestro
Pappalardo di Catania, deceduto nella guerra del 1940. Egli m’impartì
lezioni di pittura, durante un nostro breve soggiorno a Catania, per
motivi di salute di mio Padre.
Ricordo quando mi disse che, se gli interessava il movimento di
un’onda, per realizzarlo sulla tela, tanto stava ad osservarla dalla
riva, fin quando si accorgeva di aver perduto la nozione del tempo. In
questo modo, m’insegnò che il lavoro non s’improvvisa. Sotto la sua
direzione eseguii dei bouquets di rose su seta per cuscini da salotto;
anche questi rimasero. Quante
cose rimasero! E cominciammo tutto daccapo con
pacienza,
come diceva mio Padre, sperando in Dio e nella ricostruzione, dopo una
guerra non certo scatenata dagli Italiani che furono invitati ad
abitare la Libia per attendere ad attività pacifiche. Nei miei ricordi:
il saluto delle sirene delle navi e quello del treno Bengasi-Barce, il
rotolio delle ruote e il trotto dei cavalli, quando andavamo in
carrozza alla Grotta del fiume Lete; il ghibli gradito ai Libici,
perché facilita la maturazione dei datteri; a me gradito, perché arriva
vestito di rosso, colorando il cielo e porta gli aromi, raccolti
correndo, nell’immensa Cirenaica del Sud; il suo caldo secco mi
dinamizzava; al contrario di persone che rendeva boccheggianti; i
trilli delle Arabe in festa, accompagnati da darbuke e maghrune
(tamburelli e zufoli). Nei miei ricordi è rimasta la cantilena:
Hammuss,
zarriaaa; hahauiaaa, fullll.
Noi ragazzini, correvamo ogni pomeriggio a comprare i ceci, i semi di
zucca, le noccioline americane, le fave abbrustolite, che il venditore
ambulante, forse cieco, ci porgeva nel minuscolo cono di carta, per un
soldino, scegliendo ogni cosa, dagli scomparti di un cassettino,
appoggiato alla sua giacchetta. È rimasta la salmodia del muezzin che
dall’alto del minareto chiamava i fedeli alla preghiera cinque volte al
giorno. Ponderatamente iniziava e finiva dicendo:
“Allah
Allakbar, Allah Allakbar”
(Dio è grande! Dio è grande!).
Nei miei ricordi sono rimasti la sveglia e il silenzio delle varie
caserme militari vicine e lontane che si sentivano in brevi tempi
successivi. Il silenzio mi era diventato consueto, coincideva con l’ora
in cui ero con la mia famiglia riunita a cena. La prima melodia di
tromba proveniva dal Comando truppe sul Viale Regina, in linea d’aria,
a poche decine di metri da casa mia. Sembrava dedicata non solo ai
soldatini, ma a tutte le comunità del quartiere. Nei miei ricordi sono:
la maestra Maria Maccagno, per me impareggiabile educatrice, la
cortesia di Padre Gabriele, i salti d’affetto del cagnolino (Papà lo
trovò sotto il peso delle macerie della scala, si volevano un gran
bene, così finì per lui un amico straordinariamente grande), un
professore di Caluso, preparato e senza sussiego, le mar ce delle
fanfare militari, le acrobazie degli aerei dell’aeroporto di Benina, la
periferia desertica, trapunta di margherite gialle della nostra precoce
primavera, i crochi bianchi dal profumo di gigli che spuntavano dopo le
piogge dall’arenile della Giuliana, l’atmosfera orientale dei soûq, dei
negozi indiani, del fonduk in confusione di merci, di genti, e di
cammelli. Molto tempo prima del nostro ritorno a Bengasi, agli ex miei
operai porsi gli auguri per l’indipendenza della Libia, da essi
desiderata e raggiunta. Non credo che ci sarà per me un altro viaggio
in Libia, come mi profetizzò quel signore, tanto meno che ci sarà per
me un breve soggiorno fra quel popolo con cui mi sentii ben inserita.
Mi dispiace di non aver visitato le meravigliose oasi dell’interno fra
cui Cufra, Gialo, Giarabub, e le città costiere archeologiche della
pentapoli, di cui Cirene era la capitale: Tocra, Apollonia, Tolemaide,
Berenice! Ma ci saranno sempre per me i libri che mi parlano di loro
per sognare di loro. Ho raccontato la mia “Storia di famiglia” con i
suoi passi lirici e soprattutto tragici, questi ultimi, dalla fiducia
in Dio raddolciti e resi utili, per una vita migliore. Quando,
guardando dalla mia casa, vedo le navi che solcano l’Ionio, verso sud,
affido loro un bacio da portare in Cirenaica. Anche se non è così, per
me tutte le navi dirette a sud vanno in Libia.
“Buon tempu e malu tempu non durano di tuttu tempu”,
dicevano gli antichi siciliani. Un giorno Dio potrebbe rinnovarmi la
gioia della partenza verso le amate sponde e dischiudermi le emozioni
degli arrivi festosi! Chissà!
Alle prime luci dell’alba si sentiva un insolito andirivieni per le
corsie del piroscafo, era il personale di bordo che anticipava il
lavoro del riassetto e annunciava:
“Terra! Terra!”.
Balzavamo dalle cuccette e guardavamo dagli oblò, dimenticando le
trentasei ore di mal di mare. Com’era bello!
 |
|
Bengasi Palazzo Municipale |
Salve Cirenaica!
Terra
del silfio, di Evesperide, di Berenice,
degli
asfodeli, delle artemisie.
Terra
di Apollonia, Taukira e Tolemaide
le
cui importanti vestigia, ricordano i sonanti nomi,
terra
risorta da catastrofi.
Salve
Cirenaica !
Terra
di Cirene da cui ti nomasti,
che
tu possa tramandare ai posteri,
la
classica armonia del tuo passato!
Che
tu possa continuare nei tuoi filosofi,
nei
tuoi marabutti, nei tuoi eroi, nei tuoi studiosi.
Aristippo,
Teodoro, Sinesio, Callimaco,
San
Marco, il Cireneo, Ibn Ghazi,
Muktar
e altri, sono ancora presenti.
Salve
Cirenaica !
Nonostante
il fluire dei secoli,
ci
vengono incontro i cirenaici,
aleggia
l’ellenismo sotto il tuo bel cielo,
vivono
vicini costruttivamente
ortodossi,
ebrei, cristiani, islamici.
Francesca Privitera
Giarre,
18 giugno 1995
 |
 |
|
Cirene
- La zona degli altari nel santuario di Apollo.
|
Cirene
- Rilievo dell’agorà, dono votivo di un vincitore nella corsa dei carri.
|
 |
|
Cirene.
Afrodite Anadiomene scoperta nelle Grandi Terme.
|
 |
|
Il the nel deserto |
|