| LA STANZA di LORENZO BANDINI |
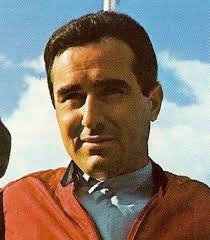 |
| LorenzoBandini |
|
BIOGRAFIA
Lorenzo
Bandini (Barce, 21
dicembre 1935 – Monaco, 10
maggio 1967)
è stato un pilota
automobilistico italiano. Carriera Lorenzo
Bandini
nacque il 21 dicembre 1935 a Barce,
nella Libia
italiana,
oggi nota come al-Marj.
Il padre Giovanni e la madre Elena Martignoni, emigrati per lavoro dall'Emilia-Romagna,
si conobbero e si sposarono nella cittadina africana dove nel 1934 ebbero
la prima figlia Gabriella. Nel 1941 la
famiglia dovette lasciare l'Africa a
causa della seconda guerra
mondiale e
si trasferì a San
Cassiano di Brisighella,
paese paterno,
dove acquistarono un albergo; dopo la morte del padre, sequestrato e
fucilato
in una rappresaglia durante
la guerra civile(era
iscritto al Partito Fascista
Repubblicano),
la madre portò i due figli a vivere nel suo paese
d'origine, Reggiolo,
dove Bandini studiò in una scuola di
avviamento professionale e
iniziò a
lavorare come meccanico[1]. Gli
esordi Nel 1950 si
trasferì a Milano, ove trovò impiego presso l'officina di Goliardo
Freddi,
padre della futura moglie di Bandini, Margherita. Fu proprio Freddi a
lanciare
Bandini nel mondo dei motori. 10
giugno 1956, Castell'Arquato-Vernasca: la prima gara di Lorenzo, con la
Fiat
1100 TV Il
10 giugno 1956 fece
il suo debutto assoluto nelle gare automobilistiche: il suocero Freddi
gli
prestò, infatti, la propria FIAT 1100
TV bicolore per partecipare alla Castell'Arquato–Vernasca.
Bandini si piazzò quindicesimo. Il pilota romagnolo cercò di maturare
quanta
più esperienza possibile, partecipando a diverse gare ed ottenendo, il
9
settembre 1956,
un bel secondo posto alla Lessolo-Alice,
seguito da un
altrettanto lusinghiero 3º posto nella classica corsa in salita
genovese Pontedecimo-Passo dei Giovi con
una impegnativa Fiat
8V da
2 litri. Nel 1957conquistò
un altro secondo posto nella Garessio-Colle San Bernardo,
mentre nella Pontedecimo-Passo dei Giovi fu
soltanto 5° di classe con la stessa Fiat
8V con
cui aveva gareggiato l'anno precedente. 14
ottobre 1956: La Fiat 8V di Bandini taglia il traguardo al Passo dei
Giovi. Si
piazzerà al 3º posto di classe Nel 1958 colse
il primo successo: su una Lancia
Appiacoupé Zagato concluse
al primo posto nella classe 1100 Gran Turismo Preparato alla Mille Miglia.
Ormai
incoraggiato, ottenne negli anni a seguire ottimi risultati uno dietro
l'altro:
ancora nel 1958 un
quinto posto nella Coppa Intereuropa a Monza ed un terzo posto alla
Coppa d'Oro
di Sicilia, dove disputò la sua prima corsa in monoposto, con una
Fiat-Volpini
di Formula Junior. L'anno successivo (1959)
si aggiudicò la classe 500 a Monza nel Trofeo Ascari con una minuscola
Berkeley, proseguì la stagione con la Formula Junior (dapprima con la
Volpini,
successivamente con la Stanguellini) ed ottenne numerosi risultati di
rilievo:
tre vittorie (Catania-Etna, Innsbruck,
Coppa della Madunina a Monza), un secondo posto (Pontedecimo-Passo dei Giovi),
un terzo posto (Coppa d'Oro di Sicilia) e due quarti posti (Coppa S.
Ambroeus a
Monza e Grand Prix de Monaco di Formula Junior) più altri risultati
minori. Nel 1960 proseguì
l'attività correndo quasi esclusivamente con la Formula Junior ed
ottenendo
altri risultati positivi, tra cui la vittoria al Gran Premio della
Libertà
a Cuba,
ritagliandosi
così una certa fama. Il
suo sogno era,
però, l'approdo in Formula
1.
Nel 1961,
dopo aver vinto la Coppa Junior a Monza sperava
di poter pilotare una Ferrari,
nel frattempo messa a disposizione, su iniziativa della FISA,
di un giovane emergente, ma la scelta cadde su un'altra stella nascente
dell'automobilismo italiano, Giancarlo Baghetti.[2] Formula
1 L'esordio
in Formula L'esordio
in
Formula 1 sembrò rimandato, ma Mimmo
Dei,
patron della Scuderia Centro Sud,
offrì a Bandini un contratto per la stagione 1961.
Il debutto ebbe luogo il 18 giugno al Gran Premio del
Belgio,
ma la sua gara si concluse dopo 20 giri a causa di
un guasto. La stagione fu in effetti sterile di risultati (Bandini non
collezionò neanche un punto, vedendo la bandiera a scacchi solo
in Gran Bretagna e
in Italia),
ma le doti del giovane pilota romagnolo erano ormai palesi e veniva
ritenuto
una delle migliori speranze dell'automobilismo italiano.[3] A
dicembre Enzo
Ferrari gli
propose, infatti, un contratto per la stagione 1962. L'approdo
in Ferrari Lorenzo
Bandini alla guida della sua Ferrari nel 1962 Il 1962 fu
una stagione deludente per la Ferrari, che soffrì la potenza delle case
motoristiche britanniche (BRM, Lotus e Cooper su
tutte). Bandini fece il suo esordio a Pau,
in una gara non valida per il mondiale, e disputò il Gran Premio di
Monaco il
3 giugno, cogliendo subito un terzo posto
dietro a Bruce
McLaren e Phil
Hill.
La Ferrari però lesinò ad utilizzarlo: Bandini tornò
in pista solo in Germania (ritirato)
e Italia (ottavo) e alla fine fu dodicesimo in classifica con 4 punti.
Bandini
comunque vinse il GP del Mediterraneo a Enna (una corsa di F1, seppur
non
valida per il Mondiale). Anche
l'anno seguente non
fu il massimo. Bandini esordì solo al quarto gran premio della stagione
(decimo
posto in Francia)
e non andò oltre il quinto posto, conquistato in tre occasioni (Gran
Bretagna, USA e Sudafrica).
A fine stagione concluse decimo in classifica con 6 punti. Il 1963 non
fu, però, un anno privo di alcun risultato: i piazzamenti nelle gare
ufficiali,
uniti alla vittoria della 24
Ore di Le Mans (con Ludovico Scarfiotti)
e ad altri risultati in prove non incluse nel calendario di F1 fecero
di
Bandini il "Campione Italiano Assoluto" dell'anno. Il
1964 e la prima vittoria Lorenzo
Bandini (a destra) nel 1964, stringe la mano ad Ilario
Bandini Bandini
venne
quindi confermato in Ferrari per il 1964,
con il ruolo di secondo pilota.[4] In
quell'anno, il pilota romagnolo ottenne i suoi risultati migliori.
Tornò sul
podio in Germania, dopo il quinto posto in Gran Bretagna, e ottenne, il
23
agosto la sua prima (e unica) vittoria in un Gran Premio valido per il
Campionato Mondiale di Formula 1: è il Gran Premio
d'Austria a Zeltweg,
che si aggiudicò precedendo di 6,18 secondi Richie
Ginther su
BRM. Il terzo posto in Italia fece da
antifona all'ulteriore podio conquistato nell'ultima gara, in Messico.
Qui Bandini giunse nuovamente terzo, dopo aver dato un valido
contribuito al
compagno di scuderia John
Surtees,
avendo tenuto dietro per diversi giri il diretto
rivale di quest'ultimo per la conquista del titolo, Graham Hill,
con cui ebbe
anche un piccolo incidente. Surtees vinse il titolo grazie anche al
contributo
di Bandini, che si classificò quarto con ben 23 punti. Poche settimane
dopo la
gara, però, si scatenarono alcune polemiche sul comportamento tenuto
dal pilota
italiano, che ricevette una lettera in cui venne criticato per la sua
guida
da Peter Garnier e Jo
Bonnier, rispettivamente segretario e
presidente della Grand Prix
Drivers' Association.[5] Bandini
respinse le accuse, liquidando il contatto con Hill come normale
incidente di
gara.[5] Il
prosieguo in rosso Lorenzo
Bandini - Ferrari 312 Il 1965 sembrò
aprirsi bene, con la vittoria della Targa
Florio con Nino
Vaccarella.
Il 30 maggio a Monaco, seconda gara della stagione
(la prima, in Sudafrica, si era conclusa con il quindicesimo posto),
Bandini
concluse secondo, dietro a Graham Hill, ma il prosieguo di stagione non
fu dei
migliori. Per quanto il motore lo tradisca solo una volta (in Gran
Bretagna),
Bandini andò a punti solo in Germania (sesto), in Italia (quarto) e
negli USA
(quarto). Alla fine della stagione giunse
sesto con 13 punti. Bandini
era deluso,
ma anche la stagione 1966 non
risultò delle migliori. Nonostante l'ottimo avvio, col secondo posto
a Montecarlo e
il terzo in Belgio che
lo proiettarono in testa alla Classifica Mondiale dopo i primi due GP,
Bandini
vide la bandiera a scacchi solo altre due volte (sesto posto sia
in Olanda che
in Germania).
Alla terza gara, il Gran Premio di
Francia,
ottenne la pole
position e
condusse in testa per due terzi di gara prima
di subire la rottura del cavo dell'acceleratore. Il pilota, che aveva
tentato
di ovviare al guasto utilizzando un fil di ferro preso da una rete
metallica a
bordo pista,[6] fu
costretto a desistere poco dopo, terminando undicesimo, con undici giri
di
distacco dal vincitore. A Monza riuscì
a prendere la testa, ma, già al secondo giro, fu costretto a rientrare
ai box.
Rientrato in pista ebbe successivamente un guasto alla pompa della
benzina e si
dovette ritirare. Si presentò quindi al Gran Premio degli
USA tra
i favoriti[7] e,
al termine delle qualifiche, risultò terzo. In gara fu poi protagonista
di un
lungo duello con Jack
Brabham,
ma, forse per l'eccessivo sforzo richiesto alla
propria vettura,[7] il
motore cedette, proprio mentre l'italiano era in testa alla corsa. Al
termine
della stagione risultò, quindi, solo nono in classifica con 12 punti. Il
1967 e la tragica fine Il 1967 iniziò
ottimamente per Bandini, che si impose, in coppia con Chris
Amon,
nella 24
ore di Daytona.
Il successo ottenuto, oltre a dare morale al pilota,
gli garantì una discreta popolarità oltreoceano, tanto che pareva
dovesse
prendere parte alle prove della 500 miglia di
Indianapolis.[8] Ad
aprile, poi, Bandini si impose nuovamente alla 1000
km di Monza,
sempre in coppia con il neozelandese. Il pilota
romagnolo parve aver reagito nel migliore dei modi allo sfortunato
biennio
1965-66 ed Enzo Ferrari gli affidò la prima guida della rossa, al
fianco di
Amon.[9] La
Ferrari non si
presentò al Gran Premio del
Sudafrica,
esordendo direttamente nel secondo appuntamento
mondiale: quello di Monaco.
Bandini riuscì a partire dalla seconda posizione, a fianco di Jack Brabham,
e al via riuscì a
prendere il comando. Intanto, l'australiano aveva avuto un cedimento al
motore
e aveva inondato d'olio la pista, su cui scivolò, al passaggio
successivo,
l'ignaro Bandini, che perse due posizioni, a vantaggio di Hulme
e Jackie Stewart.
L'italiano cominciò quindi una lunga rimonta e al 61° dei 100 giri
previsti
fece segnare un distacco di appena 7,6 secondi dal neozelandese. Ma
proprio a
questo punto l'italiano trovò sulla sua strada due doppiati: Pedro Rodríguez e Graham Hill.
Il primo si fece
facilmente superare, ma il secondo, forse memore dei fatti del Gran Premio del
Messico 1964,
lo ostacolò per diverse tornate, facendogli
aumentare ulteriormente il distacco. Ma gli sforzi per sorpassare il
pilota
della Lotus lo avevano spossato, tanto che nei giri seguenti il divario
crebbe
fino a 20 secondi. Poi, all'82º giro si consumò la tragedia: Bandini
giunse
alla chicane del porto a velocità
nettamente superiore a quella
di solito tenuta dai piloti in quel punto e la sua Ferrari, dopo aver
colpito
una bitta di ormeggio delle navi, decollò e ricadde pesantemente a
terra,
capovolgendosi e prendendo fuoco. Le fiamme furono alimentate dalle
balle
di fieno poste
a bordo
pista. I soccorsi non intervennero tempestivamente, anche perché si
pensava che
il pilota fosse stato sbalzato fuori dalla vettura e fosse finito in
acqua,
com'era successo ad Alberto
Ascari nel 1955.[10] Solamente
quando l'incendio venne domato e l'auto fu raddrizzata, tre minuti e
mezzo dopo
l'impatto, si scoprì la terribile realtà: il pilota, ormai privo di
sensi, era
ancora all'interno della Ferrari[10].
Bandini venne trasportato al nosocomio di Monaco in
condizioni critiche, con una profonda ferita alla milza e ustioni su
oltre il
60% del corpo.[10] Purtroppo
ogni tentativo dei medici di salvargli la vita risultò vano e Lorenzo
Bandini
si spense, dopo settanta ore di agonia, il 10 maggio 1967. Le
indagini, aperte
dopo l'incidente, fecero chiarezza sulle cause. Senz'altro la prima fu
la
stanchezza di Bandini,[9] la
cui vettura fu trovata in quinta marcia, anziché in terza (come avrebbe
dovuto
essere nel punto dell'incidente). Ma pure un insieme di altri fattori
avevano
contribuito a rendere più drammatica una vicenda che forse poteva
concludersi
meno tragicamente: pesanti accuse sono lanciate in proposito contro la
sicurezza dell'autodromo monegasco, specie a causa della presenza sul
tracciato
di lamiere metalliche e bitte per l'ormeggio (pericolosissime se
colpite a
quelle velocità dalle monoposto da corsa), nonché di balle di fieno per
attutire gli impatti (ma anche le prime ad incendiarsi). In più i
soccorritori
non indossavano tute antincendio e i primi estintori a loro
disposizione erano
di scarsa capacità: in tal modo essi non si erano potuti avvicinare a
distanza
sufficiente per spegnere le fiamme all'auto di Bandini, né erano
riusciti a
domare il rogo tempestivamente. La
morte di
Bandini, amatissimo dagli appassionati di Formula 1 del tempo e dagli
italiani
tifosi della Ferrari, lasciò un grande vuoto nel mondo automobilistico. Dopo
il funerale celebrato
a Reggiolo il
13
maggio 1967[11],
cui partecipano centomila persone[12],
la salma viene tumulata nel Cimitero di Lambrate[13]. Vittorie
assolute ·
1959-4
ottobre: Trofeo Jean Behra, su Fiat-Stanguellini Formula Junior ·
1959-22
novembre: Coppa Madunina (prima batteria),
su Fiat-Stanguellini Formula Junior ·
1959-22
novembre: Coppa Madunina (prova finale),
su Fiat-Stanguellini Formula Junior ·
1960-28
febbraio: Gran Premio de la Libertad, su Fiat-Stanguellini Formula Junior ·
1960-15
agosto: Gran Premio di
Pescara (seconda
batteria), su Fiat-Stanguellini Formula Junior ·
1960-2
ottobre: X Prova Addestrativa C.S.A.I.,
su Fiat-Stanguellini Formula Junior ·
1960-9
ottobre: Coppa Junior Modena (seconda
batteria), su Fiat-Stanguellini Formula Junior ·
1961-19
marzo: Coppa Junior Monza (prima batteria),
su Fiat-Stanguellini Formula Junior ·
1961-19
marzo: Coppa Junior Monza (prova finale),
su Fiat-Stanguellini Formula Junior ·
1961-23
luglio: Gran Premio di Messina (prima
batteria), su Lotus
20-Ford Formula Junior ·
1961-15
agosto: 4
Ore di Pescara (con Giorgio
Scarlatti),
su Ferrari 250 TRI/61 ·
1962-18
agosto: Gran Premio del Mediterraneo,
su Ferrari
Dino 156 F1 ·
1963-15/16
giugno: 24
Ore di Le Mans (con Ludovico Scarfiotti),
su Ferrari
250 P ·
1963-7
luglio: Trofeo d'Auvergne, su Ferrari 250 TRI/61 ·
1964-23
agosto: Gran Premio d'Austria,
su Ferrari
Dino 156 Aero F1 ·
1965-9
maggio: Targa
Florio (con Nino
Vaccarella),
su Ferrari
275 P2 ·
1967-5
febbraio: 24
Ore di Daytona (con Chris
Amon),
su Ferrari
330 P4) ·
1967-25
aprile: 1000
km di Monza (con Chris
Amon]],
su Ferrari
330 P4) Vittorie
di classe ·
1958-21/22
giugno: Mille
Miglia (con
"Cialy") (classe 1100 Gran
Turismo Preparato, su Lancia Appia Zagato) ·
1959-12
aprile: Trofeo Ascari (con Raffaele Cammarota)
(classe 500 Gran Turismo, su Berkeley 500 coupé) ·
1959-27
settembre: Catania-Etna (classe Formula
Junior, su Fiat-Stanguellini Formula Junior) ·
1962-6
maggio: Targa
Florio (con Giancarlo Baghetti)
(classe 2000 Sport, su Ferrari
196 SP) ·
1962-18
novembre: Trofeo d'Autunno (classe 2500 Gran
Turismo, su Simca-Abarth 1300 coupé) ·
1963-5
maggio: Targa
Florio (con Ludovico Scarfiotti)
(classe 2000 Sport, su Ferrari
196 SP) ·
1963-25
agosto: Ollon-Villars (classe oltre 2000 Sport
Prototipi, su Ferrari 250 TRI/61) ·
1963-24
novembre: Coppa F.I.S.A. (classe 1600
Prototipi, su Alfa Romeo Giulia TZ) ·
1965-16
maggio: Gran Premio Roma (classe 2000 Sport,
su Ferrari Dino 166 P) ·
1966-5
giugno: 1000 km del
Nurburgring (con Ludovico Scarfiotti)
(classe 2000 Prototipi, su Ferrari Dino 206 S) ·
Campionati
italiani Nei
diversi
Campionati Automobilistici Italiani del periodo 1959-1966, Lorenzo
Bandini si
laurea Campione assoluto d'Italia per 4 anni di seguito; questo il
quadro
completo dei risultati conseguiti: ·
1959:
Campionato Italiano Formula Junior - Allievi: 2° ·
1960:
Campionato Italiano Formula Junior: 6° ·
1961:
Campionato Italiano Assoluto: 2° ·
1961:
Campionato Italiano Formula Junior: 7° ·
1962:
Campionato Italiano Assoluto: 2° ·
1963:
Campionato Italiano Assoluto: 1° ·
1964:
Campionato Italiano Assoluto: 1° ·
1965:
Campionato Italiano Assoluto: 1° ·
1966:
Campionato Italiano Assoluto: 1° Riconoscimenti Nel 1992 il
comune di Brisighella istituì in onore del compianto ferrarista il "Trofeo Lorenzo
Bandini",
assegnato ogni anno al miglior pilota
emergente della F1 (ad eccezione del 1997,
trentennale della morte di Bandini, quando il trofeo fu assegnato
a Luca Cordero di
Montezemolo,
e del 2003,
quando a riceverlo fu Michael Schumacher). Note 1.
^ Annese, Lorenzo
Bandini. Immagini di un pilota, p.
13 2.
^ Giancarlo
Faletti, Nestore Morosini, Baghetti,
gentleman al volante,
in Corriere
della Sera, 28 novembre 1995, p. 44. (archiviato
dall'url originale il). 3.
^ Ferruccio
Barnabò, Compito difficile per Bandini contro
Stirling Moss e Brabham,
in Stampa Sera, 2 settembre 1961,
p. 6. 4.
^ Bandini,
l'anti-divo del volante, in La Stampa,
4 agosto 1964,
p. 8. 5.
^ a b Giorgio
Bellani, Il pilota Bandini risponde alle accuse: «Non
sono scorretto
durante le corse», in La Stampa,
17 dicembre 1964, p. 8. 6.
^ A
Brabham il Gran Premio di Reims. Sfortunata la prova di Bandini,
in Stampa
sera, 4 luglio 1966, p. 11. 7.
^ a b Via
libera a Clark,
Corriere dello Sport. URL
consultato il 14 dicembre 2011. 8.
^ Bandini ha conquistato gli
USA, Corriere
dello Sport. URL
consultato il 14 dicembre 2011. 9.
^ a b Casamassima, Storia
della Formula 1, pag.
736. 10.
^ a b c Ferruccio
Bernabò, Lorenzo Bandini lotta con la morte dopo
un'operazione durata
sei ore, in La
Stampa,
8 maggio 1967, p. 5. 11.
^ Mass Held For
Bandini, in The New York Times,
12 maggio 1967, p. 56. 12.
^ 100,000 at
Bandini Rites, in The New York Times,
14 maggio 1967,
p. 64. 13.
^ Lorenzo
Bandini,
su Findagrave.com. URL
consultato il 31 gennaio 2015. Bibliografia ·
Pier
Attilio Trivulzio, Nato per correre. La
vera storia di Lorenzo Bandini, Milano,
Baldini&Castoldi, 1967. ·
Pino
Casamassima, Storia della Formula 1,
Bologna, Calderini Edagricole, 1996, ISBN 88-8219-394-2. ·
Giuseppe
Annese e Marco Serena (a cura di), Lorenzo
Bandini. Immagini di un pilota, Faenza, Edit Faenza, 2003. ·
Enzo
Ferrari, Piloti che gente..., San
Lazzaro di Savena, Conti Editore, 2003. ·
Vincenzo
Borgomeo, Dizionario della Ferrari.
Storia, piloti, gare e modelli, Roma, Newton &
Compton editori,
2004, ISBN 88-541-0182-6. ·
Renato
D'Ulisse, Da Hill l'americano al
computer Lauda. I ferraristi 1961-1978, in Ferrari
Opera Omnia,
Milano, RCS Quotidiani, 2007. ·
Aldo
Zana, L'Epopea delle Sport e Prototipi,
Vimodrone, Giorgio Nada Editore, 2011, ISBN 978-88-7911-535-3. ·
Cesare
De Agostini, Bandini. La speranza d'Italia,
Milano, Giorgio Nada Editore, 2013, ISBN 978-88-7911-587-2. |
| Homepage Ernandes | vai su | Indice Bandini |